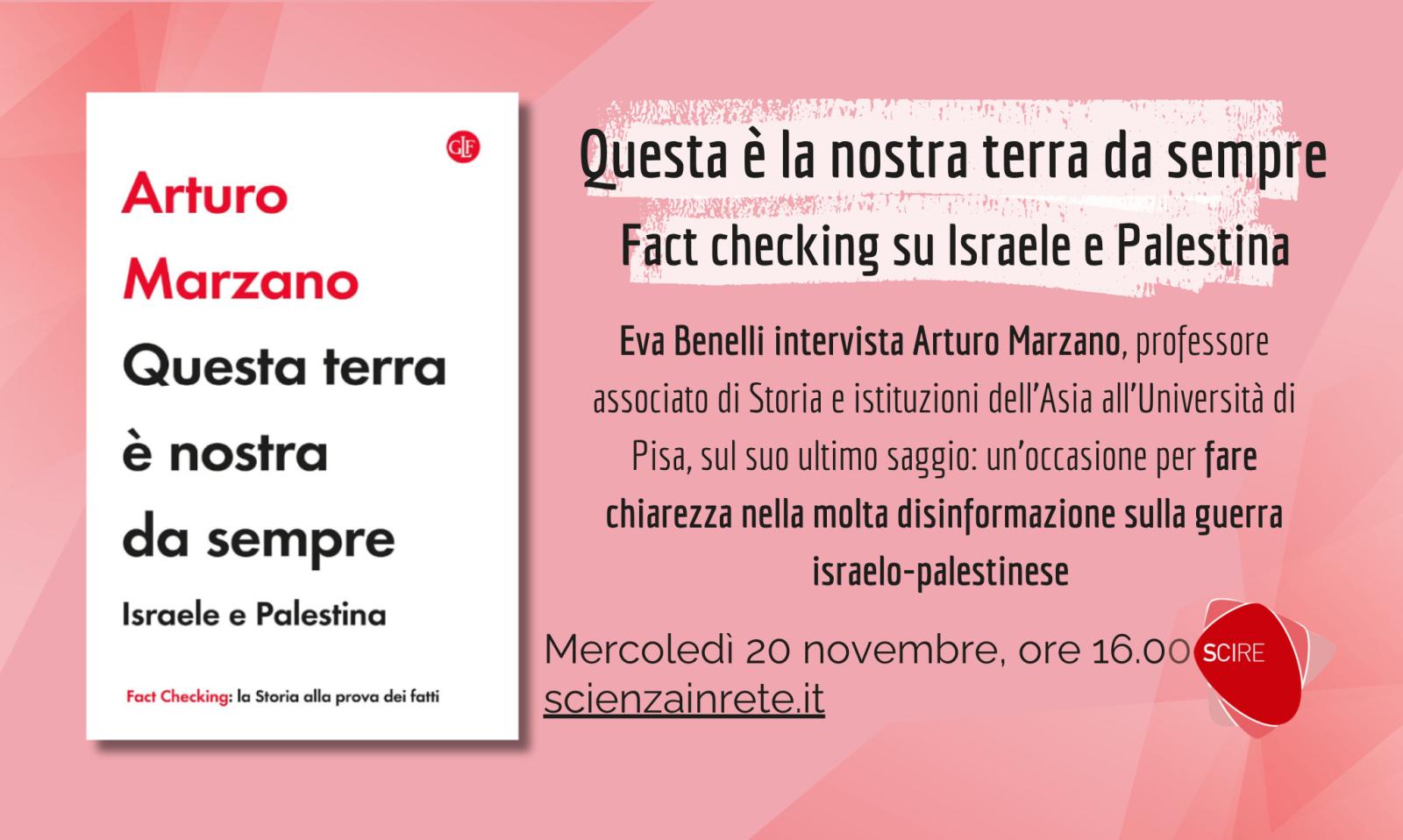Lo sappiamo, a Berlino sono un po’ egoisti e alquanto ossessionati dal “rigore dei bilanci”. Ormai, quel “fiscal compact” che pretendono i tedeschi con prussiana determinazione, sta un po’ stretto agli altri europei. Tuttavia dobbiamo riconoscere che in Germania l’economia va molto meglio che in Italia. Non solo – e forse non tanto – in termini di stabilità finanziaria. Ma anche – e forse soprattutto – in termini di economia reale. Nella produzione di beni e servizi.
La Germania è ancora la locomotiva della lenta Europa.
L’industria tedesca si è fortemente rinnovata. Le fabbriche teutoniche producono più beni e di più elevata qualità che non quelle italiane. Le imprese esportano di più. E pagano salari maggiori ai loro dipendenti. Insomma, il sistema industriale tedesco funziona bene e ha retto benissimo alle sfide della nuova globalizzazione.
Perché?
Non lo so. Sono un giornalista scientifico, non un economista. Per questo ho deciso di chiedere un po’ in giro a persone meglio informate. Così ho posto la domanda a un amico chimico, che sa di scienza e d’industria. È un amico cui tutti, in Italia e all’estero, riconoscono uno sguardo lungo. Proiettato verso il futuro.
Ecco, in sunto, la risposta.
L’industria chimica ha assunto in breve tempo un’importanza considerevole nell’economia delle nazioni più evolute […]. Il valore commerciale annuo dei prodotti delle industrie chimiche in Germania è salito [moltissimo, ndr]. Per ottenere un simile risultato devono concorrere molte circostanze che non è facile conoscere e valutare […].
In Italia il movimento delle industrie chimiche accenna a un notevole risveglio che speriamo sia foriero d’un fecondo avvenire […]. Ma per elevarsi a nazione industriale mancano all’Italia ancora molti coefficienti., che dipendono più dagli uomini che dalle cose e però per potere basterebbe volere. Anzitutto vi dovrebbe contribuire l’azione del Governo e del Parlamento. Le nuove industrie sono delicate pianticelle che nel loro primo sviluppo hanno bisogno di assidue cure e magari della serra calda della protezione […].
Alle industrie chimiche sono poi naturalmente necessari i chimici. Ed è questo per noi un tasto assai doloroso. Non v’ha dubbio che in Germania esse devono la loro attuale floridezza al capitale, che da Liebig in poi è stato investito nelle scuole delle chimica, perché in nessun’altra disciplina il lavoro scientifico e quello industriale stanno in così stretto rapporto. Ora la Germania spende nelle sole università, senza contare i politecnici, in dotazione ai laboratori di chimica annualmente [molti milioni di euro, ndr], cifra che sta in triste contrasto con [gli spiccioli, ndr] assegnati allo stesso scopo dal nostro bilancio dell’istruzione superiore […]. Finalmente anche agli industriali incombono considerevoli oneri, senza di cui ogni progresso diverrebbe impossibile. Il tempo in cui una fabbrica poteva menare fruttuosa esistenza lavorando sulla base di alcune ben sperimentate ricette è finito […]. Le industrie non possono fiorire se abbandonate agli empirici, ci vogliono chimici educati alla ricerca, molti e ben retribuiti. La Germania ne impiega circa 4mila, di cui la maggior parte possiede cultura accademica.
Ringrazio il mio amico chimico. Trovo sia la sua diagnosi sia la sua terapia di grande lucidità. E soprattutto di interesse generale. Non riguardano solo la chimica, ma l’intera industria italiana. Il mio amico, infatti, sostiene che la crisi nel nostro paese è strutturale. Dipende dal rapporto tra scienza e industria. L’Italia, a differenza della Germania, persegue ancora un modello di «sviluppo senza ricerca». E questo modello non è più sostenibile.
Questa situazione può essere cambiata, però. Gli ostacoli, infatti, sono più negli uomini che nella cose. Perché possiamo diventare una nazione industriale competitiva nell’era della nuova globalizzazione. Però tutti dobbiamo volerlo. E tutti dobbiamo agire in concerto. Il Governo e il Parlamento, che devono prendersi cura di quelle delicate pianticelle che sono le nuove industrie. Investendo di più. Ma, soprattutto, “credendoci” di più e agendo di conseguenza. Le università e i centri di ricerca, che devono raggiungere i livelli quantitativi e qualitativi tedeschi. E devono formare molti più giovani tecnici preparati.
Ma anche gli industriali devono darsi una mossa. Devono rendersi conto che «il tempo in cui una fabbrica poteva menare fruttuosa esistenza lavorando sulla base di sperimentate ricette» è finito. Che occorre innovare il prodotto e il metodo produttivo. Non sulla base di scelte empiriche. Ma investendo nella scienza. E favorendo l’ingresso in azienda di tecnici laureati con alta qualificazione scientifica. Perché questa e non altra è la strategia (è la sinergia) che consente alla Germania di avere successo nell’economia del nuovo secolo. E questi e non altri sono i motivi per cui l’industria italiana ha difficoltà a interpretare il secolo nuovo.
Ah, dimenticavo. Il mio amico è un triestino. Lavora presso l’università di Bologna, dopo essersi formato all’estero e a Roma. Si chiama Giacomo Ciamician. E ha scritto queste cose in un saggio intitolato, appunto, I problemi chimici del nuovo secolo.
Il saggio è stato pubblicato nel 1905. È stato poi ripreso da Antonio di Meo nel volume su La storia della chimica italiana, Vignola, 1996. E poi ancora da Lucio Russo ed Emanuela Santoni nel libro Ingegni minuti, Feltrinelli, 2010.