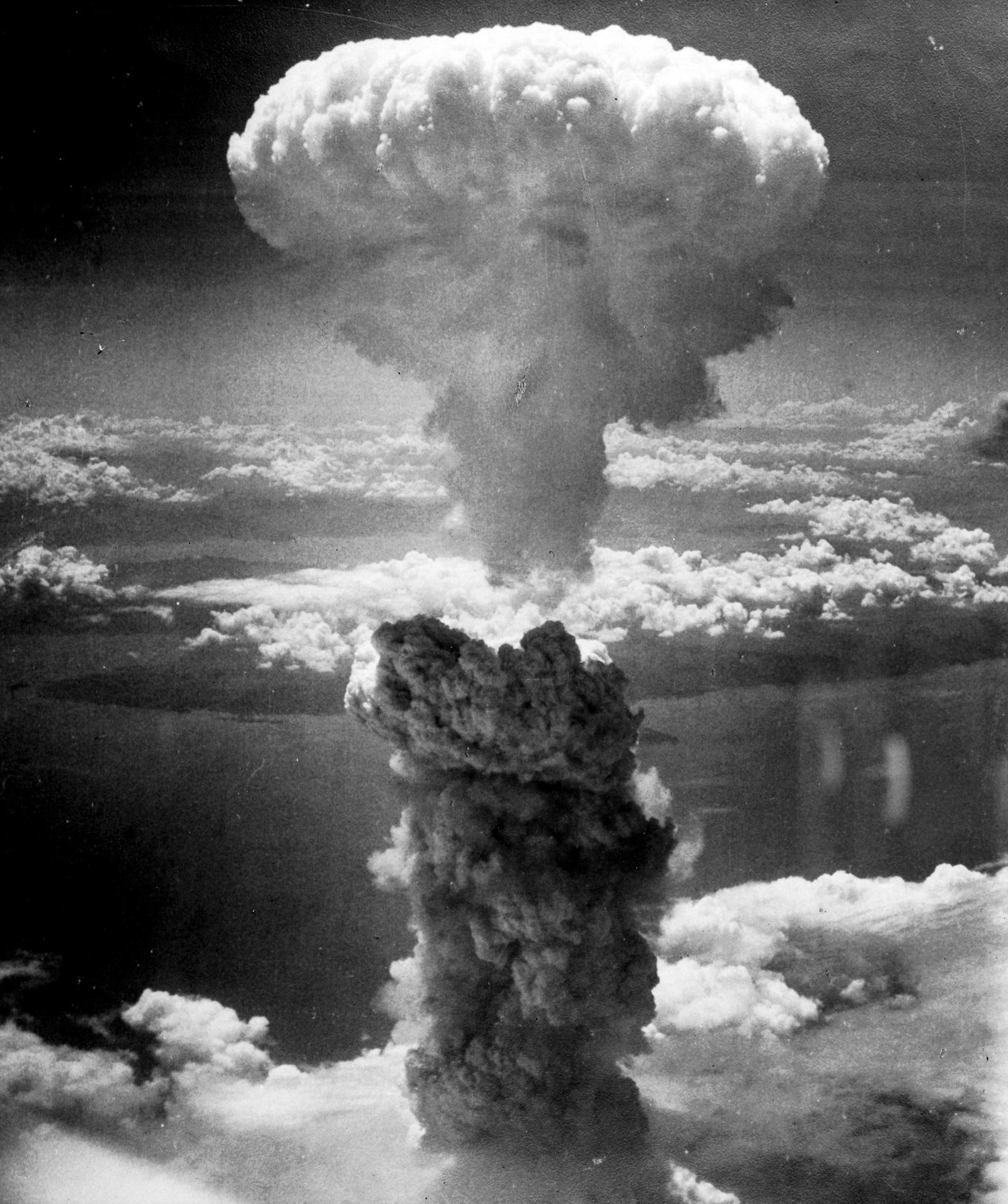È uscito per Adelphi Il cuore selvaggio della natura di David Quammen, raccolta aggiornata di reportage e saggi scritti in vent’anni di viaggi attorno al mondo alla scoperta della natura e dei suoi abitanti, umani e non umani. In questa intervista di Laura Scillitani l’autore ci racconta il libro e come è nato, parlando di natura selvaggia, viaggi, equilibri naturali, pandemie e coesistenza.
Nell'immagine: David Quammen nel Parco Nazionale di Yellowstone. Crediti Ronan Donovan
Non è sicuramente facile parlare di temi come la perdita di biodiversità, la comparsa di nuovi virus, l’evoluzione o il rapporto con animali pericolosi tenendo i lettori incollati al libro con tomi di quattrocento e più pagine, ma David Quammen ci riesce splendidamente. Complici i suoi viaggi avventurosi, lo stile ironico, tagliente e molto diretto dei suoi scritti, la capacità documentaristica di descrivere luoghi, situazioni e persone. È uscito la scorsa settimana per Adelphi Il cuore selvaggio della natura, che Quammen ha presentato alla ventottesima edizione del Festival Letteratura di Mantova.
L’ho incontrato nella splendida cornice di palazzo Castiglioni, cuore della città animata dalla kermesse letteraria, in una giornata rinfrescata da continui scrosci temporaleschi. Quammen è gentile, sorridente e disponibile, ascolta fissandomi attentamente con i suoi occhi chiari dietro gli occhiali dalla montatura leggera; ripesca dalla memoria i mille aneddoti della sua vita avventurosa e sceglie con molta cura le parole con cui rispondere; chiacchierando scopriamo anche di avere conoscenze in comune nel mondo della conservazione. Dopo la presentazione al festival ripartirà alla volta del Mozambico, dove lo attende un workshop sulle foreste, e poi si sposterà in Tasmania, per raccogliere storie per il suo prossimo libro, che tratterà del cancro e della sua evoluzione.
Il cuore selvaggio della natura raccoglie, aggiornandoli, i principali reportage scritti per National Geographic, nei quali Quammen parla di temi a lui molto cari come la difesa della ricchezza di specie che popolano il nostro pianeta, i diritti dei popoli indigeni, il profondo legame tra benessere umano e benessere del pianeta. Non mancano storie tragiche di estinzioni e conflitti umani-fauna che si creano a causa dell’erosione degli ambienti naturali, come nel caso della drammatica convivenza tra persone e scimpanzé nell’Uganda occidentale, o tra Masai e leoni in Tanzania. Ma ci sono anche molte storie di speranza, come quella del parco di Gorongosa, esempio virtuoso di coinvolgimento delle comunità locali a sostegno di una natura che pareva soccombere sotto il peso delle azioni umane e che è oggi invece florida e pulsante, o come i progetti di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e reintroduzione di specie minacciate di estinzione in Cile e Argentina.
Nell’introduzione de Il cuore selvaggio della natura scrive che un libro di Edward Wilson ha contribuito in modo molto importante alla sua scrittura di saggi e reportage sul mondo naturale. Ci spiega in che modo?
Sì, è stato intorno al 1985. All’epoca scrivevo regolarmente su una rivista, avevo una rubrica di scienze naturali. Lessi che nell’isola di Guam, nel Pacifico occidentale, le numerose specie indigene, endemismi unici dell’isola, stavano scomparendo. All’inizio il perché di questa scomparsa era un mistero, poi fu scoperta la causa: si trattava di un serpente esotico trasportato accidentalmente con gli aerei provenienti dalla Nuova Guinea o dalle Isole Salomone. Un serpente arboricolo, predatore di uccelli. Gli uccelli di Guam erano una preda molto facile: erano per così dire ingenui, non avendo mai avuto predatori naturali su quell'isola. Ho quindi iniziato ad approfondire l’argomento, e fu un’illuminazione, come se avessi aperto una porta su una grande stanza buia o se avessi strisciato attraverso un cunicolo in una caverna scoprendo i dipinti di Lascaux. Le isole generano nuove specie uniche e molto vulnerabili: la maggior parte delle estinzioni avvenute negli ultimi trecento anni sono tutte avvenute sulle isole. Cercai la letteratura scientifica su questo problema, e uno dei libri fondamentali che trovai fu The theory of island biogeography(La teoria della biogeografia insulare) di Ed Wilson e Robert McArthur, pubblicato nel 1967. Il testo non solo parla delle caratteristiche peculiari delle isole, ma introduce il problema della frammentazione: ovunque ci sia una porzione di habitat circondata da terra inospitale, anche quella funziona come un'isola, ed è soggetta a estinzione. Questo libro fu un testo imprescindibile per l’ecologia e la conservazione che ispirò molti ricercatori a occuparsi della frammentazione dell’habitat e degli ecosistemi insulari. E portò me a dedicare otto anni alla scrittura del mio libro, The song of the dodo. Nel corso delle mie ricerche conobbi Wilson, che mi fu di grande aiuto, e diventammo amici. Scrivevo già di conservazione, ma il suo libro fu fondamentale per me e per realizzare il mio primo saggio.
Una sua cifra stilistica caratteristica è quella di documentarsi anche attraverso viaggi lunghi e avventurosi, alla scoperta di luoghi naturali selvaggi e in compagnia dei ricercatori di campo...
Uno dei miei principi ispiratori nella scrittura di saggi sul mondo naturale – o di qualsiasi altro argomento – è “andare là, essere sul posto”. Vuoi scrivere dei gorilla in Congo che stanno morendo a causa forse di una epidemia di ebola? Vai là. Vuoi scrivere dell’estinzione delle specie in Tasmania? Vacci. Questo è quello che faccio. E questo libro raccoglie vent'anni di questo principio, di essere sul posto per viverlo e raccontarlo. Nel 1999 il National Geographic Magazine mi ha assunto per scrivere storie per loro, fornendomi risorse che hanno reso più semplice per me fare questo lavoro, perché mi hanno mandato nei luoghi selvaggi di tutto il mondo per scrivere di creature selvagge.
Appunto nel 1999 il National Geographic la ingaggiò per la sua prima spedizione, che forse resta uno dei suoi viaggi più avventurosi, il “megatransect”, un'idea dell’ecologo conservazionista Mike Fay, un percorso a piedi di oltre 3600 chilometri che si snoda lungo il bacino del Congo, in mezzo a posti impenetrabili, per raccogliere e documentare tutta la biodiversità presente. Nel libro scrive che all’inizio hanno dovuto insistere perché lei partecipasse, ce lo racconta?
All’epoca stavo lavorando al libro Alla ricerca del predatore alpha. Facevo avanti e indietro dalla Romania, dove andavo sul campo per l’orso bruno, e poi in Australia per passare del tempo con gli aborigeni e raccogliere materiale sui coccodrilli. E mi chiamarono dal National Geographic per chiedermi se volessi andare ad attraversare a piedi il Congo con quel tizio. Risposi che sembrava interessante, ma ero molto impegnato, e li salutai. Addio. Ma poi loro chiamarono ancora, e ancora. Fu una buona negoziazione, offrirono più fondi e soprattutto la promessa di non distruggere e cambiare i miei scritti, lasciando inalterato il mio stile. Accettai.
Quammen ci tiene a indicarmi che la sua ultima raccolta è proprio dedicata a Mike Fay e a Nick Nichols, il fotografo della spedizione. Fu la più grande occasione della mia vita di essere davvero nella natura selvaggia. È stata un'opportunità meravigliosa. È stato difficile fisicamente. È stato scomodo. Ma l’ho amato. Attraversammo a piedi dei luoghi così selvaggi che nessun essere umano era mai stato lì, nemmeno le tribù che una volta chiamavamo pigmei, gli Aka, i Baka, i Ba-benzélé e i Gombi, le piccole persone della foresta. Questi popoli vivevano nella foresta in molte parti dell'Africa Centrale, ma alcune delle aree che abbiamo attraversato erano così selvagge che non c'erano. E come sapevamo che non c'erano? Perché non c'erano segni di machete sugli alberi, nemmeno di cinquant’anni prima. E se non c'erano segni di machete, allora non c'erano state persone.
Una cifra comune dei suoi viaggi è portare i lettori con sé in territori naturali remoti, in cui l’impronta umana è quasi assente. Ma appunto quasi, perché ci sono sempre tracce di popolazioni presenti o passate. Per diversi pensatori, soprattutto nel passato, selvaggio è sinonimo di assenza della presenza umana. Lei cosa ne pensa, quando possiamo parlare di selvaggio?
Concordo nel fatto che gli umani sono stati quasi ovunque; ma non sul fatto che la selvaticità implichi necessariamente l’assenza umana, perché ci sono popoli locali, indigeni, che hanno vissuto in molti di questi territori selvaggi per migliaia di anni, e senza alterare più di tanto la foresta perché hanno da sempre vissuto in piccole popolazioni con impatto minimo sull’ambiente. C’è un intenso dibattito sul significato di wilderness, un concetto che dovrebbe essere ridefinito. È un termine che non uso molto nel libro proprio per questo motivo. Ma wild, selvaggio, è un termine che chiunque riconosce, e quindi nell’introduzione ho cercato di definirlo; il titolo in inglese è infatti il battito del cuore selvaggio. Una tigre all’interno di una gabbia allo zoo non ha molto di selvaggio, anche se si tratta di un animale feroce. Perché qualcosa possa essere selvaggio sono necessarie quattro cose. Inanzitutto la scala: deve essere grande. E poi richiede connessione, devono esserci interconnessioni tra i viventi e gli ambienti fisici. Ci devono essere i processi ecologici: fotosintesi, predazione, erbivoria, competizione, parassitismo, decomposizione. Tutti questi processi di interazione e trasformazione. E se ci sono queste tre prime cose, allora molto probabilmente ci sarà anche la quarta, la diversità ecologica. Se un posto ha tutte e quattro queste caratteristiche allora puoi dire che il cuore di quel posto sta ancora battendo.
Un suo saggio, Spillover, in cui nelle pagine finali lei parlava proprio del fatto che la prossima pandemia avrebbe potuto essere associata a un coronavirus, è diventato davvero molto famoso in Italia durante la pandemia di Covid. Il libro è stato letto da molti media come un aspetto spaventoso della natura, ma in realtà parla di come la natura possa diventare spaventosa a causa delle nostre azioni, è corretto?
Spillover è stato scritto molti anni prima del Covid. È un libro sull’ecologia e l’evoluzione. Il suo obiettivo è dire alle persone che i virus pericolosi e spaventosi che sembrano arrivare dal nulla e attaccare le persone, in realtà non sbucano affatto fuori dal nulla. Non c’è niente di magico o innaturale in questo; al contrario, è molto naturale e si basa su ecologia ed evoluzione di questi virus spaventosi che obbediscono alle leggi della selezione naturale darwiniana. Fanno del loro meglio per massimizzare il loro successo riproduttivo, proprio come fanno gli esseri umani, o i ratti, o le farfalle. Vivono nei loro ospiti naturali, se glielo permettiamo: ma se disturbiamo i loro ospiti naturali, allora sono capaci di fare un salto di specie, arrivando a noi. E se lo fanno, aumenteranno il loro successo darwiniano. Per esempio, prendiamo un virus che ha il suo ospite-serbatoio in una specie di pipistrello in pericolo di estinzione nell'Africa orientale. Quando quel pipistrello si estingue, anche quel virus si estinguerà. A meno che un essere umano non si avvicini, catturi uno di quei pipistrelli, uno degli ultimi pipistrelli in pericolo, lo porti al suo villaggio, lo mangi ed esponga così la sua famiglia al virus. E il virus si radica nella sua famiglia, poi passa a un'altra famiglia, poi a un altro villaggio e poi a un altro paese. Improvvisamente, quel virus può diventare uno degli organismi più di successo sul pianeta.
Andiamo in foreste tropicali ricche di biodiversità, e costruiamo strade, e tiriamo giù gli alberi, costruiamo campi minerari, e uccidiamo la fauna selvatica per nutrire i lavoratori. I lavoratori devono mangiare. È così che succede. È così che le foreste vengono distrutte. Le persone entrano per sfruttare una risorsa, per raccogliere qualcosa, e devono mangiare. Quindi abbattono gli alberi e mangiano gli animali. E anche se la foresta, anche se il 90% di essa è ancora in piedi, ma ci sono strade che la attraversano tutta, e ci sono persone che vivono nei villaggi, diventerà quella che chiamano la “foresta vuota”. La foresta esiste, è ancora in piedi, ma gli esseri umani sono entrati e hanno ucciso tutta la vita selvatica.

David Quammen con un diavolo della Tasmania, ritratto durante una indagine sui tumori. Crediti foto Menna Jones
Nel libro Alla ricerca del predatore alpha affronta invece il nostro rapporto con i grandi predatori, o meglio ancora con quelle specie che sono per noi pericolose, un tema oggi fortemente attuale, anche in Italia. Nel testo lei definisce la relazione con questi animali «cruciale nel determinare il modo in cui noi umani interpretiamo il nostro ruolo nel mondo naturale». Cosa ne pensa della coesitenza con i grandi predatori?
È sempre molto complesso, difficile, il tema dei predatori e del conflitto. Nel libro, che ormai ha vent'anni, dedico molta attenzione al fatto che i grandi predatori sono pericolosi, costosi, scomodi. Voglio dire, sono animali meravigliosi, importanti, ma sono anche queste cose: scomodi, pericolosi e costosi. Ci sono benefici e costi associati alla presenza di questi animali. E i costi li pagano i locali che condividono l'habitat con loro, nella maggior parte dei casi le persone più povere che vivono nella foresta o nel paesaggio circostante, lottando per nutrire i loro figli, per mantenere qualche mucca, per mantenere qualche pecora. E per affrontare questo problema, il primo passo è riconoscerlo e riconoscere che le persone lontane, che invece hanno soprattutto i benefici, devono trovare modi per pagare di più i costi.
E poi c’è un altro discorso fortemente legato ai grandi predatori. Nel corso della vita incontriamo pericoli di ogni sorta, e tutti prima o poi moriremo. Ma ci sono alcuni tipi di pericoli che le persone accettano, e altri che non vogliono accettare. Ci sono tipi di rischio a cui siamo abituati, come quello di essere investiti da un autobus. Lo accettiamo. Non ci spaventa. Realizziamo semplicemente che devi essere cauto, che devi guardare prima di attraversare una strada trafficata. Ma il rischio di avere predatori nella foresta è diverso, ci spaventa, ci mette in condizione di chiederci cose come: «Posso camminare nella foresta? I miei figli possono camminare nella foresta?». Io vivo in Montana, per esempio, sai che se esci devi prestare attenzione, devi rispettare delle regole, e avere il bear spray.
Lei ha sicuramente avuto una vita avventurosa. Che emozioni ha provato nel trovarsi in posti così remoti, così a contatto con la potenza della natura? Si è sentito indifeso, o al contrario connesso all’ambiente in cui si trovava?
Io sono una persona molto razionale. Naturalmente provo molte emozioni, ma non sono quello che si potrebbe chiamare una persona spirituale, quindi non mi sono sentito come dire, “a contatto con lo spirito della foresta”. Ma ero molto felice e onorato, e mi sono sentito umile a essere lì. Uno dei nostri colleghi, il pilota Player Crosby, che non camminava con noi ma faceva avanti e indietro tra le piccole piste di atterraggio, mi disse: «Non dimenticarti che se precipiti nella foresta, la foresta è tua amica, puoi sopravvivervi». Gli risposi «La foresta non è tua amica. La foresta vuole le tue molecole. È affamata. Tutto nella foresta è affamato. Se sei ferito, la foresta vuole il tuo sangue. Ci sono i parassiti, le zanzare. La foresta ha fame delle tue molecole. Quindi se muori, la foresta ti divorerà in fretta e riciclerà le tue molecole. Non sentirti male per questo, è quello che accade nella natura: è un continuo mangiare, e riprodursi, e morire e essere riciclati. Accade a ogni singolo essere vivente: siamo tutti uniti in questo destino». E io mi sentivo e mi sento a posto con tutto ciò. Questo era il modo in cui mi sentivo connesso, sapendo che il calcio e il potassio del mio corpo sarebbero diventati qualcos’altro per piccoli nuovi esseri viventi, fossero esse formiche o zanzare. Detto ciò, non volevo morire, volevo uscire da lì sano e salvo. Ma ero consapevole di tutto questo, e mi pareva giusto.
Torniamo al cuore pulsante della natura. La biodiversità, come ben descrive nei suoi libri, è molto importante, fondamentale. Ma è in pericolo, sta attraversando un'enorme crisi, a causa soprattutto delle azioni umane. Cosa si deve fare per sensibilizzare le persone su questo argomento, renderle consapevoli della loro importanza?
Raccontando storie. Storie di avventure, di magnifici animali, di bellissime piccole creature. Storie di una natura che è selvaggia e ha un battito in sé. Non dobbiamo per forza usare il termine a volte ostico “biodiversità”. È importante che ci sia intrattenimento, divertimento nell’educazione. Questo non significa indorare una pillola, mettere dello zucchero sulla medicina amara. È più come un panino farcito: ci puoi mettere dentro due diversi ingredienti, e se lo prendi sarai interessata solo a uno di questi, ma lo provi lo stesso perché contiene qualcosa che ti piace.