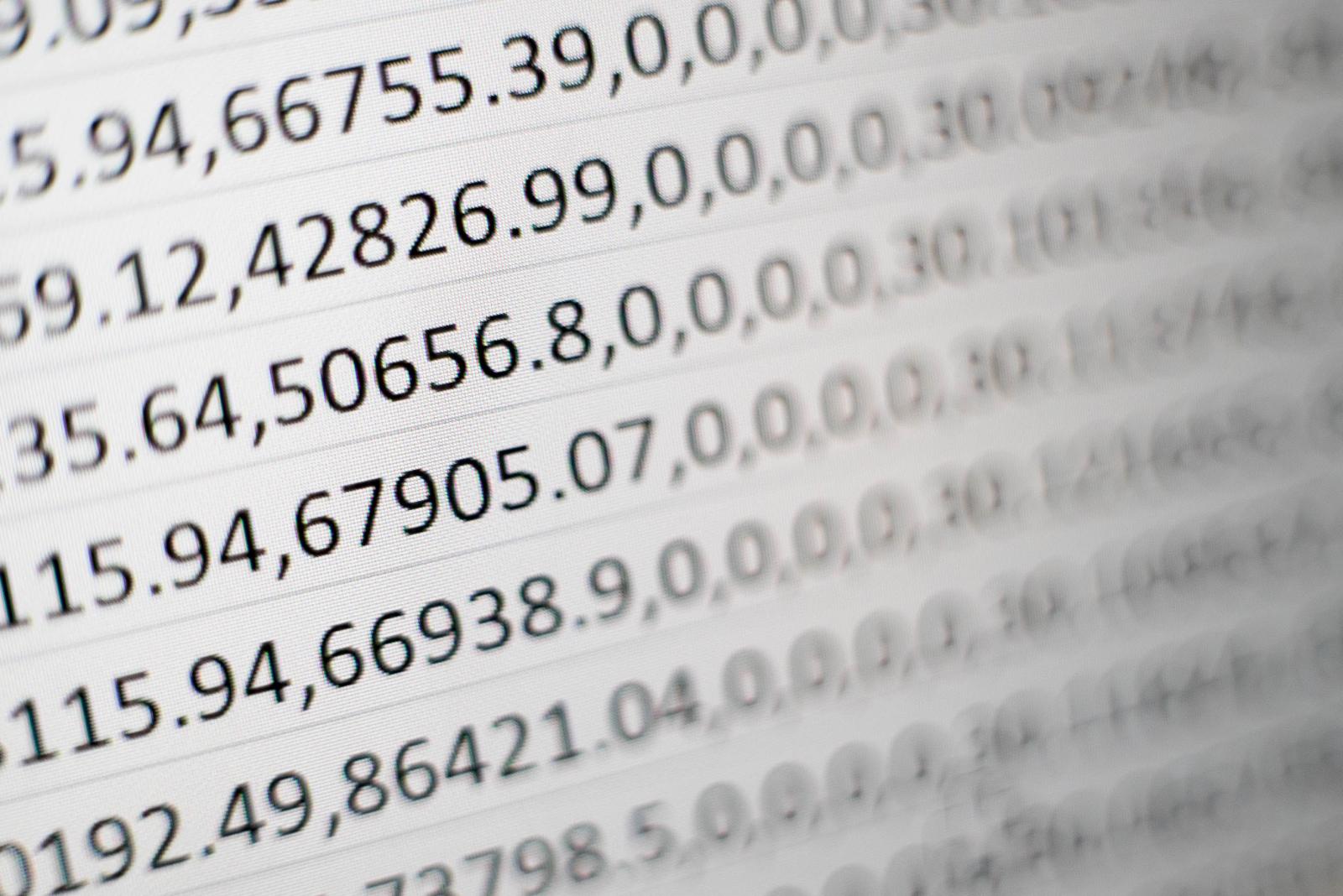
Luca Carra recensisce Numeri visti di sbieco (Edizioni Clichy), di Tommaso Maccacaro e di Claudio Maria Tartari: rispettivamente un fisico e uno storico che s'inoltrano in un viaggio “da -1 a infinito”.
Crediti immagine: Mika Baumeiste/Unsplash
I numeri hanno anche una storia, che più si retrocede nel tempo più sfuma in leggenda e si mescola volentieri anche con antichi riti e religioni. Il bello del libro di Tommaso Maccacaro e di Claudio Maria Tartari (Numeri visti di sbieco, Edizioni Clichy, 2023) è che si tratta davvero, come recita il sottotitolo, di una «insolita passeggiata da meno uno a infinito».
Prima del meno uno, in realtà, venne l'uno, la cui invenzione si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si conta già nel Paleolitico superiore, se si interpretano le tacche sugli ossi di Lembombo (Sudafrica) e di Ishango (Lago Edoardo) come una prima forma di numerazione. Una tacca sola è l’unità, alla quale seguono spontaneamente le successive, mettendo in grado l’uomo di rappresentare con una certa finezza, per esempio, i concetti di scarsità, abbondanza e sufficienza relativi al cibo da mangiare. Potrebbe quindi non essere un caso che in Sanscrito la parola “numero” derivi da namas, che vuol dire “dose di cibo”, in greco dalla parola nomos (regola, legge) e in romano nummus, che sta a indicare la quantità di misura in uno scambio. Ma, tornando al numero 1, gli autori osservano come in lingua zulu si dica nyi che significa “stato di solitudine”.
Doveva ben essere forte la solitudine dell'uno, in attesa che arrivassero gli altri man mano che le lineette incise sui legni e sugli ossi nelle società primitive trovassero ciascuna il suo nome. Benché la prima serie a formarsi sia stata quella dei numeri naturali, è curioso notare come all’inizio non ci fosse lo zero, concetto controverso e per molti secoli rifiutato sia dai Romani sia dagli altri popoli mediterranei che proprio non riuscivano a digerire questo non-numero.
Come spesso accade nella storia remota della aritmetica è nella valle dell’Indo intorno al III secolo aC che ci dobbiamo spostare per trovare nel Manoscritto di Bakhshali un sistema metrico decimale comprensivo anche del numero zero. Che per la cronaca si chiama “zero” dal persiano antico sef(e)r, che indica il vuoto, che poi trasmigrerà nell’arabo zifr e che Fibonacci tradurrà come zephirum.
Lo zero provoca qualche imbarazzo ai matematici, perché se nelle somme e sottrazioni non porta problemi, nella moltiplicazione e soprattutto nella divisione sì. Il fatto che un numero diviso per zero sia un’operazione senza senso lo si stabilì solo ai tempi di Newton e Leibniz, che con il calcolo infinitesimale in qualche modo ci misero una pezza, ma è bene sapere che n/0 ossessionò per secoli i più fini intelletti matematici, come l’indiano Mahavira, che dopo il fallimento del conterraneo Brahmagupta, sostenne che la divisione lasciava il numeratore inalterato, mentre Bāskara era convinto erroneamente che facesse infinito.
Anche l’infinito non è propriamente un concetto che si maneggia con facilità, e che come spiega il libro negli ultimi capitoli procurò parecchi imbarazzi a fior di filosofi e matematici. Per Aristotele valeva solo in potenza e mai in atto, quindi via dai piedi. Euclide proprio non lo prendeva in considerazione. Fu Georg Cantor a fine Ottocento che addomesticò l’infinito, anzi meglio sarebbe dire gli infiniti, mostrando come gli insiemi delle diverse serie di numeri erano sì numerabili ma con infiniti diversi. Quindi anche gli infiniti sono infiniti, come diceva Cantor «unendliche Unendlichkeiten». Qualcosa di simile - spiegano Maccacaro e Tartari, lo avevano già intuito i Jainisti nel I millennio a.C. nella regione subhimalayana. La loro matematica commista a misticismo distingueva fra numeri numerabili, innumerabili e infiniti, e fra questi si potevano distinguere cinque diverse categorie di infinito.
A questo punto avete capito che un libro così non lo scrive solo un matematico, infatti i due autori integrano competenza molto diverse: Tommaso Maccacaro è un fisico che fra i tanti incarichi che ha ricoperto è stato presidente dell’INAF, oltre che fondatore, come presidente del Gruppo 2003, del giornale che state leggendo ora. Mentre Claudio Maria Tartari è uno storico e paleografo oltre che per molti anni maestro elementare dedito all’area logico-matematica.
Si diceva dell’uno, dello zero e dell’infinito. Ma andiamo al -1. Questa esistenza negativa sfidava la logica ancora di più della non-esistenza dello zero. Almeno quella occidentale, perché nella Cina del III secolo a.C. i numeri negativi convivevano tranquillamente con quelli positivi quanto meno nei libri matematici Chiu Chang delle scuole confuciane, probabilmente perché questa notazione si accordava con la dialettica di pieno/vuoto, positivo/negativo del pensiero cinese. È il procedimento algebrico tuttavia che usa correntemente anche i numeri negativi, anche prima della sua nascita ufficiale nel IX secolo con al-Kwārizmi da cui prese il nome. Sembra però di capire dalle nostre guide che in Occidente i numeri negativi si fecero strada dal XIII secolo grazie all’influsso della matematica necessaria ai commerci, che certo avevano bisogno di annotare i debiti, oltre che i crediti, e quindi quantità con un “-” davanti, da cancellare il prima possibile. Nel Rinascimento i numeri negativi smettono di essere considerati “numeri assurdi”. Anzi, questi diventano cool, per esempio con la nota identità di Eulero eiπ=-1. «Dunque» scrivono Maccacaro e Tartari «-1 può essere visto come una sintesi di saggezza: è il risultato di un opportuna ma semplice combinazione di alcune delle più significative entità matematiche: uguaglianza, moltiplicazione e potenza dei tre numeri più famosi della matematica».
È ovvio che gli autori non hanno scelto mai numeri banali ma per una ragione o per l’altra sempre interessanti, talvolta molto problematici. Si pensi a √2, la cui soluzione costò la vita al pitagorico Ippaso di Metaponto. O al “numero più grande del mondo”, che non riveleremo. O infine alpha, ovvero 1/137, venerato dai fisici come la costante di struttura fine, che «si ottiene dividendo il quadrato della carica elettrica e per il prodotto della velocità della luce c e della costante di Planck h e moltiplicando il tutto per 2 π».
Splendido. Feynman la definì «uno dei più grandi misteri della fisica». E chi sono io per contraddirlo? Le pagine che Maccacaro e Tartari dedicano ad alpha danno al dilettante l’impressione di uno snebbiamento, che però dura poco. Il brutto, ma in fondo il bello dei libri che parlano di fisica e matematica, è che ti portano ad annusare delle prelibatezze che non potrai mai mangiare.



