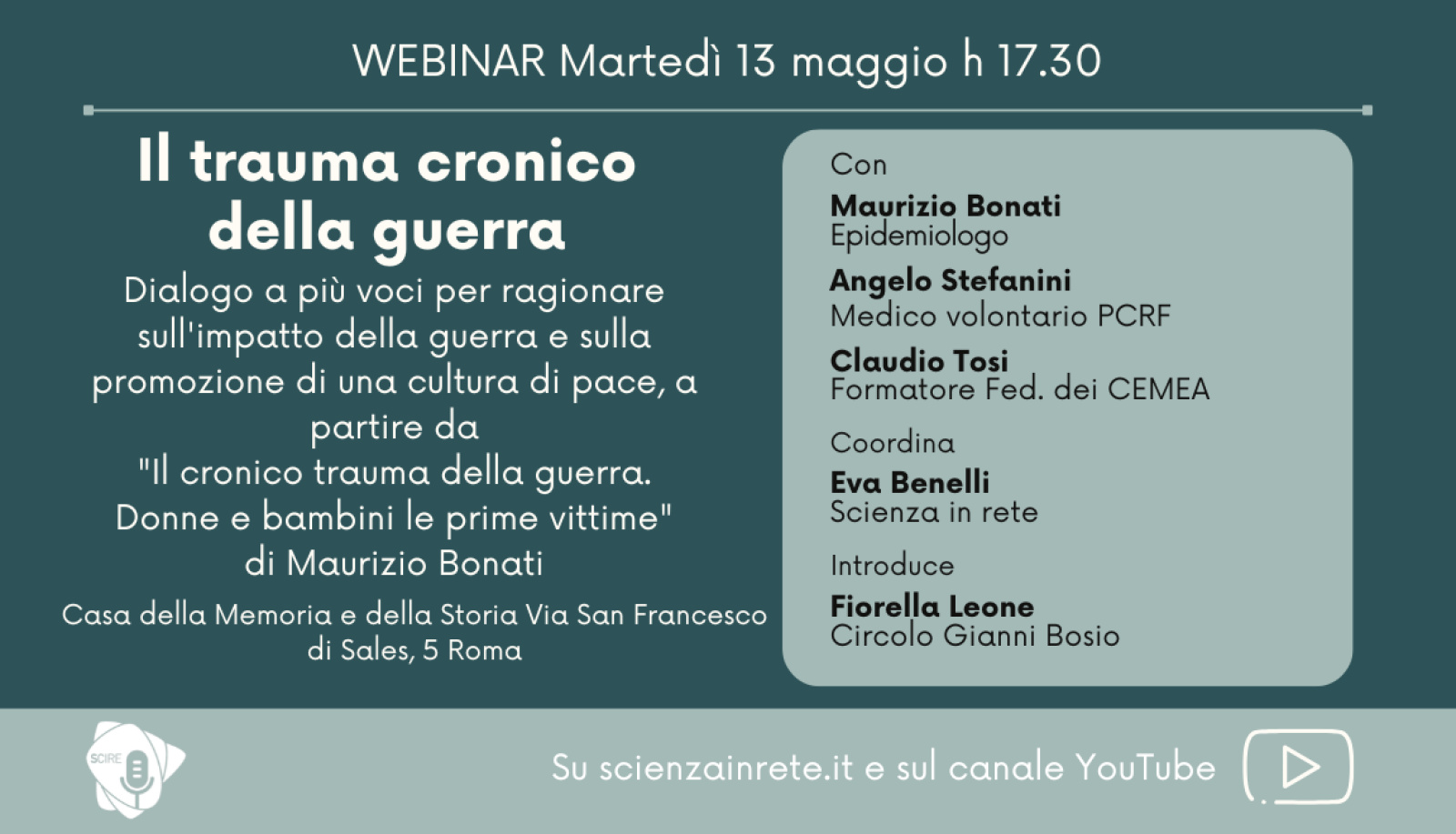Mercoledì prossimo, 27 novembre, si tiene a Milano, presso l’Università Bocconi, il II Incontro dei Dialoghi di Scienza del Gruppo2003: "Scienza e industria. Ricerca e innovazione in biomedicina”.
Il rapporto tra scienza e industria è un tema importante, probabilmente
decisivo per il nostro paese. Perché viviamo nell’economia della conoscenza, in
cui una parte sempre più rilevante dei servizi e dei beni che vengono scambiati
ha un alto tasso di conoscenza aggiunta. In particolare di conoscenza
scientifica. Si calcola, per esempio, che poco meno di un terzo dell’economia
mondiale sia costituita dalla produzione e dallo scambio di beni e servizi
hi-tech, ad alto tasso di conoscenza scientifica aggiunta. Si calcola, ancora,
che il 75% della crescita economica degli Stati Uniti dal dopoguerra a oggi sia
dovuto alla conoscenza scientifica che si è trasformata in beni e servizi
innovativi.
L’Italia
ha difficoltà evidenti a competere nella nuova economia della conoscenza. Per
tre motivi strutturali.
Primo: il paese nel suo complesso non è abbastanza attrezzato per svolgere un ruolo da protagonista nella società globale della conoscenza.
Secondo: l’Italia ha una specializzazione produttiva nella media e bassa tecnologia. Si dice che ha, da oltre mezzo secolo, adottato un “modello di sviluppo senza ricerca”.
Terzo: il trasferimento del sapere dai luoghi di produzione della conoscenza scientifica (università, enti pubblici) fa fatica a raggiungere i luoghi dello sviluppo tecnologico (le imprese).
L’Italia è un paese poco attrezzato per l’economia della conoscenza. In
particolare per quella componente, peraltro maggioritaria, dell’economia della
conoscenza che si fonda sulla scienza. Ce lo dicono, in particolare, due
indicatori generali: quello relativo agli investimenti in Ricerca e Sviluppo
(R&S) e quello relativo al numero di laureati. Ci sono alcuni paesi, come
Israele e la Corea del Sud, che ogni anno investono oltre il 4% del Prodotto Interno Lordo (Pil) in R&S.
Ci sono altri paesi (Giappone, Svezia, Finlandia) che investono in R&S
intorno al 3,5% del Pil. Ci sono, infine, altre paesi che si avvicinano quasi
al 3% (Usa, Germania). Lo scorso 22 ottobre il governo di Pechino ha
annunciato, con soddisfazione, che la Cina ha raggiunto il 2,0% del Pil negli
investimenti in R&S.
La media mondiale è, per
l’appunto, il 2,0%. La media europea è intorno all’1,9%. Le ultime statistiche
dell’Unione Europea e dell’OCSE ci dicono che l’Italia è a poco meno dell’1,3%:
un terzo in meno della media mondiale; meno della metà della Germania e degli
Stati Uniti; circa un terzo di Corea del
Sud o Israele. Il dato italiano, peraltro, è “drogato” dalla recessione, particolarmente
acuta nel nostro paese, che negli ultimi anni ha visto diminuire il
denominatore (il Pil) molto più velocemente del numeratore (gli investimenti in
R&S). In termini assoluti i nostri investimenti in ricerca e sviluppo
continuano a ridursi, mentre quelli di gran parte del mondo continuano a
crescere. Questo basso tasso di investimenti, per fortuna, ha più effetti
quantitativo che qualitativi. Detta in altri termini: i nostri ricercatori sono
pochi, ma buoni. Sono i più produttivi al mondo (per numero di articoli
scientifici pubblicati) dopo gli svizzeri e al pari con gli olandesi. E,
infatti, la produzione scientifica italiana è pari al 75% di quella tedesca.
Una sorta di miracolo, dato il numero (i ricercatori italiani sono appena
quarto rispetto ai ricercatori tedeschi) e la disparità di mezzi a
disposizione.
Un secondo indicatore che
ci ricorda come il nostro paese sia fuori dalla società della conoscenza
riguarda il numero dei giovani laureati. In Italia, nella fascia di età
compresa tra 25 e 34 anni, sono circa il 20%; contro il 40% della media OCSE;
il 60% o quasi di Giappone, Canada e Russia; il 64% della Corea del Sud.
Tutto questo ci parla del sistema paese. Non ancora del rapporto tra
ricerca e industria nel nostro paese. In questo ambito i numeri sono ancora più
impietosi. Gli investimenti in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nelle
imprese non superano lo 0,5% del Pil. Un quarto rispetto agli investimenti
delle imprese americane e tedesche; un quinto rispetto alle imprese giapponesi;
un sesto rispetto a quella della Corea del Sud.
Se scorporiamo i dati,
vediamo che in Italia gli investimenti pubblici in ricerca sono poco meno della
media mondiale; mentre gli investimenti in R&S delle imprese.
Sono del 60% in meno della media mondiale. Sono soprattutto le nostre
industrie che investono poco in ricerca.
Anche in termini di risorse
umane non stiamo meglio. Nelle imprese italiane ci sono 3,5 ricercatori ogni
mille addetti, contro la media OCSE di 7,5 ricercatori, la media Usa di 10
ricercatori, la media della Finlandia di 17 ricercatori ogni mille addetti.
L’intensità di innovazione, misurata come numero di brevetti per milione di
abitanti, vede ancora una volta l’Italia in affanno: nel nostro paese sono 82,
contro i 94 degli Usa, i 110 della media europea, i 134 della Francia, i 155
del Giappone, i 295 della Germania.
Questi dati indicano in
maniera chiara che il sistema produttivo italiano segue un “modello di sviluppo
senza ricerca”. In altri termini, l’Italia produce conoscenza scientifica ma
poi questa conoscenza non si trasforma in beni e servizi di qualità. E,
infatti, la nostra bilancia tecnologica dei pagamenti è da molti anni in rosso.
E la nostra dipendenza dalle tecnologie straniere tende ad aumentare. Ultimo
esempio, quello delle fonti rinnovabili. Negli ultimi anni, anche grazie a
generosi incentivi, i settori dell’eolico e del fotovoltaico in Italia hanno
subito un autentico boom. Ma la gran parte delle tecnologie sono state
acquistate all’estero (Germania, Cina). Cosicché la domanda di innovazione nel
settore energetico produce ogni anno un deficit commerciale aggiuntivo di 10/12
miliardi di euro.
Come se ne viene fuori? Vannevar Bush, in un testo consegnato al
presidente Truman nel 1945 che può essere considerato il manifesto della
moderna politica della ricerca, sosteneva che è compito dello stato realizzare
il cambiamento di specializzazione produttiva, favorendo il passaggio da
un’economia senza ricerca a un’economia fondata sulla ricerca. Lo stato ha due
compiti: aumentare gli investimenti pubblici in ricerca di base e in ricerca
applicata; favorire lo sviluppo dell’alta formazione, consentendo l’accesso
all’università a tutti coloro che lo meritano, a prescindere dal loro reddito.
Mentre tocca alle imprese, in piena autonomia, lo sviluppo tecnologico. Ovvero
la trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in beni e servizi.
Seguendo questa ricetta, gli Stati Uniti sono diventati leader al mondo
dell’economia della conoscenza.
Tuttavia agli ingredienti
di Vannevar Bush lo stato federale ne ha aggiunto un altro: ha creato
costantemente una domanda di alta tecnologia, per favorire indirettamente lo
sviluppo di un’industria hi-tech. In campo civile, ricordiamo lo spazio negli
anni ’60 del XX secolo (sbarcheremo sulla Luna, entro la fine del decennio fu
l’obiettivo indicato da Kennedy; vinceremo la guerra contro il cancro, fu
l’obiettivo indicato da Nixon nel 1970, quando la spinta propulsiva dello
spazio sembrava ormai in via di esaurimento).
Anche l’Italia dovrebbe, probabilmente, realizzare in tempi stretti un cambiamento di specializzazione produttiva, sia attraverso un netto incremento dei fondi pubblici per la ricerca e l’alta formazione sia attraverso progetti che evocano la produzione di alta tecnologia. Ma la trasformazione della specializzazione produttiva richiede anche l’emergere di una nuova classe di imprenditori con la formazione e la vocazione adatta. Imprenditori giovani e versati nelle scienze.
“Vaste programme”, avrebbe detto De Gaulle. Difficile da attuare. Ma non si può uscire da una crisi profonda senza un brusco scossone. Senza un cambiamento radicale. È nel contesto di questo cambiamento che si pone il problema di come migliorare il trasferimento del know how dai luoghi in cui si produce nuova conoscenza (Università, enti pubblici di ricerca) ai luoghi dove si trasforma quella conoscenza in beni e servizi (le imprese).
Molti ritengono che il tentativo di trasferimento diretto non funziona. Troppo diversi gli interessi legittimi di chi fa ricerca rispetto a chi fa impresa. Occorre, piuttosto, creare “luoghi adatti all’innovazione”: centri, quartieri, intere città dove ricercatori, docenti, studenti universitari, artisti, addetti alle industrie creative vivano fianco a fianco e abbiano la possibilità di contaminarsi intellettualmente. Luoghi – come l’Ivrea di Adriano Olivetti o la Silicon Valley in California o, oggi, Berlino e la Ruhr in Germania – dove le idee possano avere la possibilità di circolare in maniera libera e incontrare le gambe con cui correre.