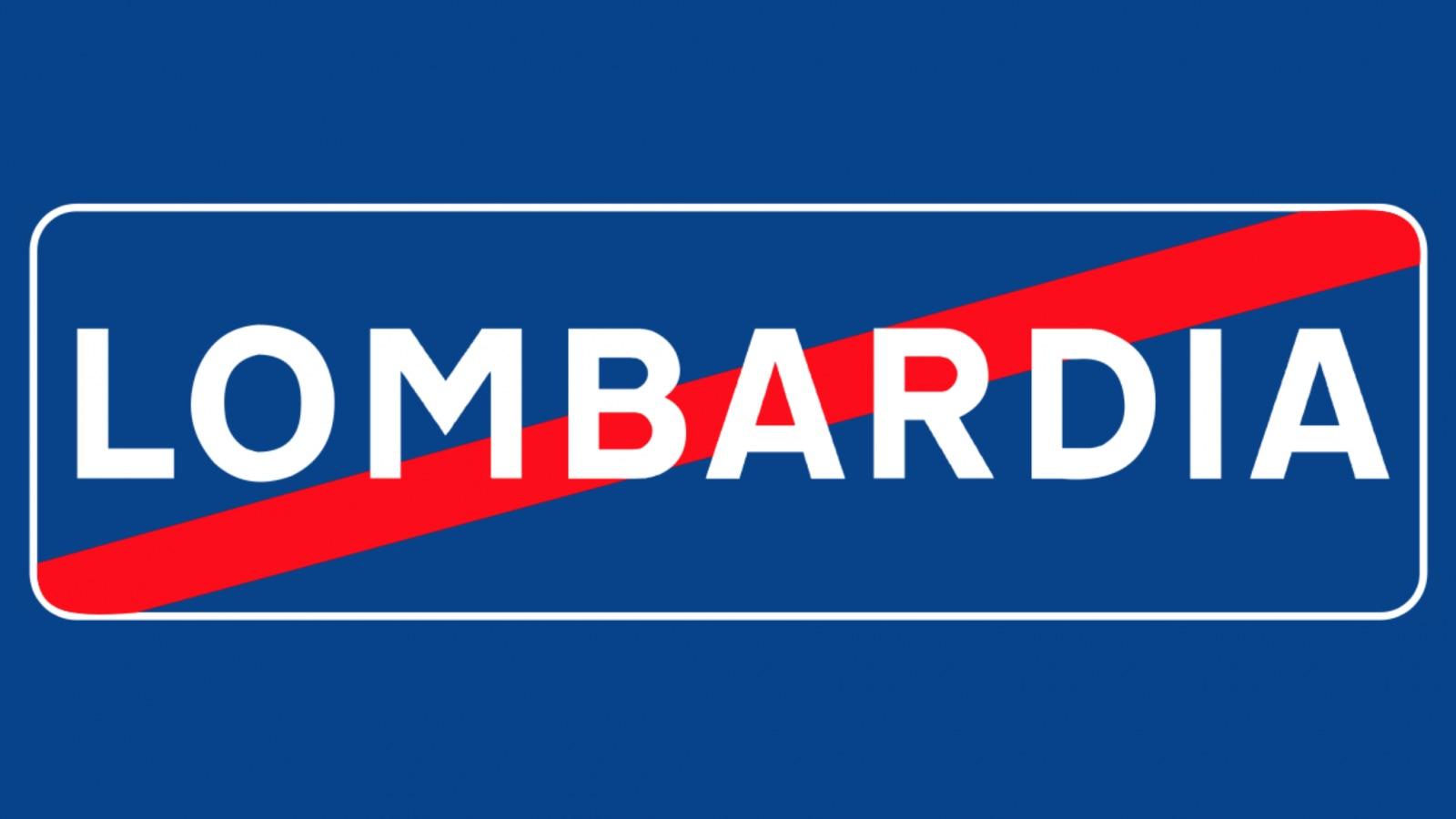
Chiamo Vittorio Demicheli alle 7:30 mentre sta venendo in auto a Milano per iniziare una nuova giornata d lavoro in ATS, di cui è direttore sanitario.
Articoli di giornali ma ora anche di riviste scientifiche confrontano la risposta della Lombardia e del Veneto rispetto all’epidemia, i cui esiti sono sotto gli occhi di tutti. E attribuiscono soprattutto alle differenze fra le due sanità territoriali questa diversa risposta, più forte in Veneto che in Lombardia. Tu cosa ne pensi?
Apprezzo i lavori che stanno cercando di affrontare l’argomento con un po’ di metodo scientifico come quello pubblicato su Scienza in rete, ma in generale sento troppe affermazioni arbitrarie e non sostenute da numeri. Vedo troppi giornalisti che si improvvisano epidemiologi e, purtroppo, troppi scienziati che utilizzano approcci giornalistici. Stiamo vivendo un’esperienza per tanti versi imprevedibile. E’ ancora tempo di dubbi, non di certezze, bisogna avere il coraggio di ammetterlo!
Mi stai dicendo che quanto successo dipende da come l’epidemia si è manifestata in diversi luoghi e non dalla capacità di risposta della sanità di questi luoghi?
E’ una cosa che non ha ancora una risposta, ma non posso escluderlo. Ci sono ancora troppi aspetti sconosciuti nel comportamento di questo virus per poter rispondere con metodo a domande complesse come l’efficacia di un intero sistema sanitario.
Allora vediamo che differenze hai osservato nell’andamento dell’epidemia in Lombardia e in Veneto, che possano darci qualche spiegazione alternativa.
Quello a cui si è assistito nei primi giorni era un contagio che correva a una velocità che non consentiva di confinarlo rincorrendolo lungo la catena epidemiologica. La ricostruzione del quoziente di riproduzione nei primissimi studi, e l’intervallo che passa fra un caso primario e un caso secondario, testimoniano di una infezione respiratoria non contenibile con la strategia che utilizziamo per le nostre piccole epidemie di meningite o di tubercolosi. Da questo punto di vista Covid assomiglia di più all’influenza, una malattia che notoriamente non si riesce a contenere ma solo a mitigare. Guardando i numeri dello studio pubblicato su Scienza in rete la progressione iniziale (fino al 2 marzo) sembra proporzionalmente identica fra Veneto e Lombardia (circa 7-8 volte). Anche guardando all’intero periodo, il contagio sembra crescere nello stesso modo (300 volte in Veneto e 270 in Lombardia). Apparentemente i due sistemi non sono riusciti a frenare la crescita.
Ma se il tasso di crescita dell’epidemia nelle due regioni è stato lo stesso, come si spiega un numero di casi e di morti così differente?
Se il tasso di crescita è stato lo stesso vuol dire che la capacità di prevenzione non è stata diversa. Le diverse conseguenze possono aver avuto tanti altri determinanti. Un’ipotesi da approfondire è senz’altro la diversa propagazione dell’infezione negli ospedali.
Però ci sono anche altri fattori non indagati. Ad esempio, la clinica ci mostra percorsi diversi nei diversi pazienti: ci potrebbero essere quindi differenze di suscettibilità individuali.
Poi consentimi di dire che confrontare un punto con un altro punto è arbitrario, bisognerebbe almeno fare un confronto tra molti contesti. Con la Francia, per esempio, che ha avuto un andamento a macchia di leopardo e conseguenze molto simili alle nostre. Oppure la provincia di Piacenza, che appartiene a un sistema sanitario diverso; ma il virus, mi pare, non se n’è accorto. La stessa Lombardia ha zone dove la propagazione e le conseguenze sono state modeste. Perché allora non confrontiamo Sondrio con Bergamo?
Cosa suggeriresti allora?
Interpretare le differenze è un buon modo per apprendere. Però bisogna farlo in modo rigoroso, analizzando tutti gli aspetti senza pregiudizi. Coloro che si occupano di confronti spaziali sanno bene quante insidie si nascondono nei dati e nelle loro rappresentazioni. In questo caso mi pare che ci sia troppa fretta: fatta un’ipotesi a priori si vanno cercare gli elementi che confortano questa ipotesi rischiando così di trascurarne molti altri. Per interpretare il comportamento di un’infezione bisogna sempre considerare simultaneamente la triade: l’agente (più o meno aggressivo), l’ospite (più o meno suscettibile) e l’ambiente (più o meno favorente).
Lasciamo perdere allora questo tipo di confronti e concentriamoci sulle nostre debolezze e sul tipo di domande che dovremmo porci adesso come italiani.
Dobbiamo tradurre le critiche in altrettanti quesiti scientifici cui dare risposta con metodo. Abbiamo urgente bisogno di analizzare i dati e la letteratura nazionale per arrivare a conclusioni provvisorie sulle caratteristiche dell’epidemia che si è sviluppata da noi, in modo da non sbagliare le prossime mosse.
Ci sono tanti aspetti interessanti. E’ apparsa carente, ad esempio, un’organizzazione che vede i medici di famiglia lavorare prevalentemente in autonomia anzichè in rete. Sta diventando chiaro che per fronteggiare un’epidemia bisogna lavorare in squadra; dovremmo tenerne conto, perché Covid non è ancora alle nostre spalle.
Un’altra debolezza organizzativa, mi pare, sta nell’accentramento degli acquisti, che ha mostrato evidenti limiti negli approvvigionamenti, che avrebbero dovuto essere (oserei dire) istantanei.
Un altro aspetto da indagare riguarda i servizi di prevenzione italiani. L’autonomia dei Dipartimenti di prevenzione e la loro scarsa integrazione coi servizi territoriali, forse, ha penalizzato le modalità di gestione dell’epidemia un po’ ovunque. Avremmo bisogno che la sorveglianza epidemiologica, cioè l’identificazione precoce, la facciano tutti i sanitari, non solo gli operatori dei servizi di prevenzione. Bisogna che chiunque si accorga di un caso, lo segnali e lo metta in isolamento immediatamente (insieme ai suoi contatti), senza aspettare la trafila tradizionale della segnalazione che va all’Ufficio d’igiene, che a sua volta dispone il provvedimento di profilassi. Purtroppo, questo modello, vecchio di mezzo secolo, è ancora prevalente in Italia.
Un altro aspetto critico riguarda i sistemi informativi, che dovrebbero essere veloci, efficienti e integrati. Le informazioni che arrivano dai laboratori, dai servizi di prevenzione e dai medici di medicina generale devono essere rapidamente integrate in un solo canale informativo. Questo servirebbe subito per ripartire con il piede giusto, ma ancora non ce l’abbiamo.
Quanto ha contribuito a questo disastro la lentezza delle istituzioni - nazionali come regionali - a rispondere con misure di chiusura tempestiva al rischio di contagio? Per esempio, quanto può avere inciso la decisione di istituire la zona rossa a Codogno ma non in Val Seriana?
Sull’efficacia delle zone rosse ho ancora molti dubbi. Certamente hanno spento il focolaio internamente ma, mi pare, non hanno impedito la sua propagazione al resto del territorio. Credo che una malattia con questo coefficiente di trasmissione sia difficile da confinare in un territorio, mentre si ferma con la riduzione probabilistica dei contatti. Siamo perciò passati al lockdown di tutta la penisola, che ha funzionato, ma con tempi lunghi perché è partito in ritardo. Se fossimo stati più veloci a fermare il paese avremmo probabilmente mitigato anche le conseguenze.
E invece abbiamo tergiversato.
Il primo caso autoctono italiano è avvenuto nella giornata del 20 febbraio, mentre le misure di confinamento sono arrivate circa 10 giorni dopo. L’Unità di crisi della Regione Lombardia ha avuto presto chiaro che non esistevano alternative. Poi ci sono state varie negoziazioni tra la Regione e il Governo, ma non mi sento di biasimare nessuno perché si trattava prendere una decisione che nessuno aveva mai preso.
Situazioni come quella della Corea del Sud o di altri piccoli paesi che apparentemente hanno fermato l’epidemia senza ricorre al lockdown non sarebbero quindi state percorribili anche da noi?
Ci sono due insegnamenti “culturali” in questa pandemia. Primo: i virus viaggiano con le relazioni sociali e non si riescono a confinare perché viviamo in un mondo fortemente interconnesso. Secondo: le tecnologie di comunicazione giocano un ruolo cruciale nel controllo epidemico.
Ma la tecnologia non basta se non c’è la chiara consapevolezza del pericolo. In paesi dove invece c’è questa sensibilità, o dove ci sono regimi che possono imporre in modo autoritario certe regole, questi strumenti possono essere più efficaci. Dal mio punto di vista quest’ultima soluzione non è auspicabile.
Le inchieste giornalistiche hanno evidenziato anche un enorme problema nelle case di riposo, in particolare a Milano e in Lombardia. Si è parlato di strage, la magistratura sta indagando e c’è chi chiede il commissariamento della Lombardia. Cosa ne pensi? L’ATS Milano ha fatto un’analisi della situazione?
Le inchieste giornalistiche sono in questo momento fortemente condizionate dall’emotività e probabilmente nascono anche da una serie di interessi contrapposti.
Anche in questo caso occorrerebbe un po’ di metodo. Anzitutto inquadrare gli eventi nel tempo. La famigerata delibera regionale ha prodotto i primi spostamenti nella seconda metà di marzo mentre i contagi, nelle RSA come altrove, sono iniziati ben prima. I trasferimenti dall’ospedale verso le RSA hanno riguardato circa 150 pazienti (su 60.000 ospiti complessivi), smistati in 15 delle 700 RSA lombarde. Pensare che questi numeri siano stati determinanti per la “strage” mi sembra poco probabile.
Resta il fatto che è stata una decisione sbagliata.
Quella delibera interessava tutta la rete della post-acuzie e ha consentito a migliaia di pazienti Covid di ottenere cure ospedaliere che altrimenti non avrebbero ottenuto. L’innesco dell’epidemia nelle RSA non penso sia arrivato dai trasferimenti dagli ospedali. Come ho già detto, i tempi non corrispondono.
Pensiamo a questo: siamo mai riusciti a tenere l’influenza stagionale fuori dalle case di riposo? Questa è una infezione respiratoria: molto più grave ma con caratteristiche di propagazione simili a quelle dell’influenza. Il contagio lo portano i parenti, come nelle case, lo portano gli operatori, gli ospiti poi se la passano fra loro. L’unico modo sarebbe stato quello di chiudere, sigillare queste residenze con grandissima tempestività, cosa che non ha fatto quasi nessuno nel nostro paese. Ma attenzione, non sarebbe bastato il semplice controllo delle infezioni nosocomiali, sarebbe servita la clausura assoluta!
Ma il numero dei morti nelle RSA è impressionante, invero in molte parti d’Italia. Dalle vostre analisi che eccesso di mortalità c’è stato nelle RSA rispetto al dato regionale?
Il numero è impressionante ma riflette, in proporzione, l’aumento di mortalità che c’è stato in tutta la popolazione. Confrontando i morti osservati con quelli attesi su base stagionale e controllando per età, le differenze tra la popolazione generale e gli ospiti delle RSA sono minime. Anzi, l’eccesso maggiore sembra aver interessato soprattutto la popolazione generale.
I dati, però, vanno maneggiati con cautela perché non sono ancora consolidati: non abbiamo ancora un quadro chiaro delle singole cause di morte e poi la stagione epidemica non è ancora finita.
Ho ricevuto parecchie segnalazioni da case di riposo che non facevano i tamponi ai loro ospiti, in modo da isolare gli infetti dai sani. Me lo confermi?
Quello sui tamponi è un dibattito surreale. In una situazione di emergenza, di fronte a un soggetto sintomatico attendere anche le poche ore che richiede lo sviluppo di un tampone è un errore madornale. In epidemia le persone con sintomi vanno trattate come casi sospetti e isolate subito, anche senza tampone. Bisogna anche dire che il tampone sbaglia una volta su dieci, quindi basare le politiche di isolamento sul tampone espone al pericolo di sbagliare. Nelle RSA c’era un livello endemico così alto che l’unico atteggiamento possibile era quello di mettere in isolamento le persone al primo sintomo. Il tampone è molto più utile per liberare le persone dalla quarantena, non per farcele entrare.
Ma visto che anche gli asintomatici potrebbero trasmettere l’infezione, bisognerebbe fare il tampone comunque a tutti, no?
Non abbiamo un’informazione certa su questo punto ma lo possiamo ipotizzare. Se fosse così dobbiamo però essere consapevoli che l’unico modo per arginare una epidemia è fermarci tutti, e fare il tampone a tutti. Non solo, dovremmo ripeterlo continuamente, perché il tampone scatta un’istantanea. Noi abbiamo cominciato a fare i tamponi ai sintomatici delle RSA (circa 3.000 a Milano). Ma se dovessimo farlo a tutti gli ospiti delle case di riposo ci vorrebbero alcune settimane, alla fine delle quali bisognerebbe ricominciare da capo. Viste le forze in campo e la disponibilità di dispositivi, significherebbe non farli a nessun altro, dagli ospedali ai medici di medicina generale. Questa è la cruda realtà: non ci sono tamponi a sufficienza, bisogna usarli con ragionevolezza!
Questo pone il problema delle scorte di dispositivi diagnostici e di protezione come camici e mascherine per proteggere prima di tutto i medici, che in questo modo sarebbero potuti andare anche nelle case dei loro pazienti per seguirli meglio di come hanno fatto.
Per questo si è cominciato da tempo a istituire Unità speciali di medici per le visite domiciliari. Ma qui c’è stato il doppio problema della insufficienza di personale e della carenza di mascherine e di camici che andrebbero cambiati a ogni visita. Di fatto al momento questo tipo di organizzazione viaggia ancora a rilento.
Ma è possibile che, con i piani pandemici chiusi nei cassetti in ogni Regione d’Italia, non si avesse la consapevolezza di dover tenere scorte ingenti di questi dispositivi?
I piani rispondono agli eventi che hai previsto e questo è stato un evento in larga misura imprevedibile. I piani pandemici di cui si parla in questi giorni e che non sono stati aggiornati per almeno dieci anni, sono piani per la pandemia influenzale. Ciò che è stato fatto in queste settimane ha in effetti seguito la struttura di questi piani, ma nel merito delle cose da fare questi piani prevedevano essenzialmente vaccinazione di massa (che per Covid ancora non c’è) e stoccaggio di antivirali influenzali (che non servono). Su mascherine e tamponi c’erano giusto due righe senza indicazione di quantitativi bastevoli a coprire tutta la popolazione.
Insomma, di cosa stiamo parlando? Nessuno si aspettava una diffusione così rapida e massiccia!
Ci stiamo avvicinando alla Fase due. Come la vedi (se la vedi)?
Non la vedo ancora bene, ma credo che a questo punto le scelte siano più politiche che scientifiche. Da un punto di vista di sanità pubblica, per ripartire bisognerebbe soddisfare alcune condizioni.
La prima è un sistema di sorveglianza esteso a tutti i medici, e non solo ai Dipartimenti di prevenzione, il che vuol dire migliaia di sentinelle tutte pronte a riconoscere le infezioni, e disporre la quarantena immediatamente, avvalendosi di sistemi informativi rapidi, integrati ed efficienti. Questa condizione non c’è ancora, in Lombardia ci stiamo lavorando.
La seconda condizione è che dobbiamo essere pronti a fermare di nuovo l’Italia se l’epidemia rialzasse la testa, questa volta però con un sistema sanitario nazionale in grado di isolare e trattare i malati non gravi in luoghi diversi dagli ospedali, gli anziani infetti in case di riposo Covid e gli altri malati in ospedali con una chiara compartimentazione fra infetti e no.
Cosa pensi della lotta politica che ha preso di mira la gestione lombarda dell’epidemia?
La voglia di ripartire senza conoscere bene e senza prepararsi adeguatamente si sposa con la voglia di dare la colpa a qualcuno. E allora dopo la sindrome cinese ecco la sindrome lombarda. Invece di confrontarsi per correggere gli inevitabili errori, prevale la rivincita nei confronti del “primo della classe” che, apparentemente, ha sbagliato il compito. Io ho visto questo sistema reagire alla pandemia con manovre organizzative rivoluzionarie che, penso, abbiano salvato migliaia di vite umane. Se la Lombardia ha sbagliato qualcosa è meglio imparare dai suoi errori piuttosto che farsi giudice.
Cosa c’è da capire che ancora non sappiamo?
Conosciamo ancora troppo poco di questo virus, del suo comportamento, della risposta immunitaria, e bisogna essere prudenti. Non abbiamo ancora capito se una epidemia di questo genere si può fermare solo chiudendo tutto o anche identificando precocemente i focolai e ricostruendo rapidamente la catena di infetti e contatti. Cosa che non siamo stati in grado di fare alla prima ondata. Eppure, avremmo disperatamente bisogno di capirlo, perché quello che ci sta dicendo l’OMS è che probabilmente questa malattia non è destinata a sparire nel nulla ma a ripresentarsi in altre ondate, probabilmente più piccole.
Cosa ti lascia questa esperienza a livello umano e professionale?
Sembra tuttora di vivere in un film dell’orrore. Ho assistito a scene e ho dovuto condividere scelte che non vorrei mai più ripetere nella mia esperienza di dirigente della sanità. In situazioni drammatiche precedenti, come l’alluvione in Piemonte, dopo i primi giorni di emergenza la situazione migliorava. Qui è avvenuto il contrario: ogni giorno che passa è peggiore di quello precedente. Capisco quindi che ci sia una gran voglia di rimuovere questo sentimento che annichilisce. L’esperienza che stiamo vivendo ha aspetti inquietanti perché è imprevedibile, e lascia più dubbi che certezze. Però bisogna partire dai nostri dubbi e provare a colmarli con metodo scientifico.
E’ troppo presto per giudicare e, soprattutto, è molto pericoloso litigare. Abbiamo di fronte un nemico dotato di una grande determinazione vitale che sfrutterà a suo vantaggio i nostri conflitti e le nostre debolezze. E’ tempo di correggere l’emozione e di far prevalere la ragione.



