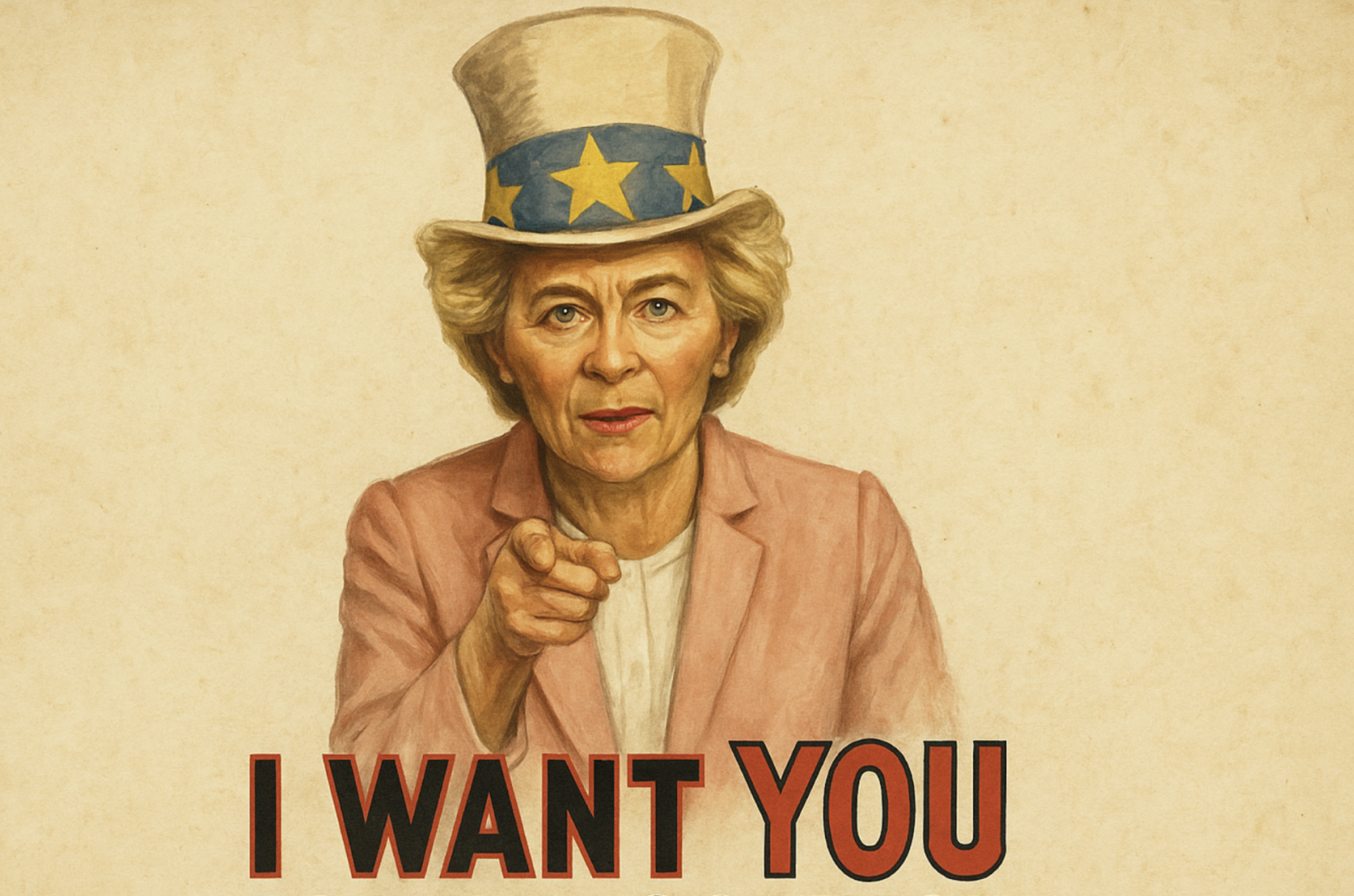In che modo e in quale misura i cambiamenti climatici colpiscono le comunità? Cosa fanno le stesse comunità per prevenire e ridurre i danni? E quali conseguenze non riescono ad evitare? A queste domande ha cercato di rispondere un'edizione speciale della rivista International Journal of Global Warming, pubblicata pochi giorni fa e dedicata interamente al tema “loss and damage”.
Per “loss and damage” (perdite e danni), si intende quella serie di impatti negativi legati ai cambiamenti climatici che non possono essere evitati né con misure di mitigazione né di adattamento. Variano molto tra Paesi e zone perchè dipendono dalla vulnerabilità sociale, ovvero dalle risorse e dai metodi che le persone e le società hanno a disposizione per fronteggiare calamità come alluvioni, uragani, siccità. É stato osservato che nei paesi più ricchi i danni sono soprattutto di tipo economico. Negli Stati Uniti sono stati calcolati danni per 100 miliardi di dollari causati dall'impatto dell'uragano Sandy lungo la costa nordorientale e dalla siccità che ha colpito il Midwest negli ultimi due anni. Nei paesi in via di sviluppo invece le conseguenze si misurano in termini di vite umane e di danni ad infrastrutture fondamentali (case, ospedali, acquedotti, etc) che i governi non sono in grado di ripristinare in tempo utile. Secondo gli ultimi dati GermanWatch, nel 2011 le vittime di eventi legati ai cambiamenti climatici nel mondo sono state più di diecimila, di cui un terzo solo in Thailandia, Pakistan e Filippine.
Gli studi pubblicati su Global Warming mettono insieme osservazioni e analisi raccolte in nove Paesi tra i più vulnerabili in Asia, Africa e Pacifico. I casi studiati coprono un'ampia varietà di fenomeni: l'impatto della variazione delle pioggie monsoniche sulla vita dei contadini in Butan, i danni causati dalla maggiore salinità delle aree costiere in Bangladesh, l'erosione delle coste nell'isola di Korsae in Micronesia, le alluvioni in Nepal, Kenya ed Etiopia, la siccità che colpisce le regioni settentrionali del Gambia e del Burkina Faso e la combinazione di alluvioni e siccità in Mozambico.
Gli autori hanno osservato che nella maggior parte dei casi le popolazioni che si trovano a fronteggiare disastri naturali legati al clima cercano di reagire, di prevenire o di adattarsi, ma spesso le misure di prevenzione e di adattamento non sono sufficienti a limitare i danni, oppure hanno dei costi insostenibili che danneggiano non solo l'economia di un Paese o di un'area, ma anche il benessere sociale (inclusi costi non economici, come mangiare meno in condizioni di scarsità alimentare, o ridurre la possibilità dei bambini di andare a scuola). In alcuni casi, le misure prese per fronteggiare un'emergenza nel lungo periodo si rivelano controproducenti. Per esempio utilizzare le riserve per la semina come cibo quando le alluvioni distruggono un raccolto, nel caso del Kenya, o costruire di barriere di protezione lungo le coste che alla lunga ne favoriscono l'erosione, in Gambia e Micronesia. Infine ci sono situazioni in cui le misure non vengono prese affatto, o perchè mancano le capacità (economiche, tecnologiche) o perchè, semplicemente, è impossibile.
Il tema dei loss and damage è relativamente recente nella ricerca scientifica e nelle politiche climatiche. All'inizio l'attenzione era puntata sulla mitigazione, ovvero come, quanto e chi deve ridurre le emissioni per evitare un aumento eccessivo della temperatura globale. Dato che i gas serra in atmosfera ci mettono anche migliaia di anni prima di essere smaltiti (la CO2, il gas serra più diffuso, ha una “vita” di 30-100 anni), un certo aumento è inevitabile (nel migliore dei casi, 1° medio in più nel 2100 rispetto ad oggi, secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC). Si è passati quindi a considerare anche le strategie di adattamento, un'impresa complessa perchè gli effetti variano molto su scala globale e regionale. Inoltre il ritardo accumulato nell'elaborare metodi e strumenti accessibili rende l'adattamento sempre più costoso. L'anno scorso a Doha è stato (timidamente) annunciato che i negoziati “prenderanno in considerazione le opzioni” per creare un meccanismo internazionale che affronti “perdite e danni” dei cambiamenti climatici. Una conquista per i Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries) e per il gruppo degli stati isolani (AOSIS) che da anni chiedono azioni più decise. Come stabilire danni e perdite (e chi dovrà pagarli) sarà uno dei temi chiave della prossima conferenza del'UNFCCC, la COP19 che si terrà a novembre a Varsavia.