Tutti, specialmente i fan della fantascienza, sappiamo
all’incirca che cos’è un ologramma: si tratta sostanzialmente di una figura in
3D “compattificata” in una superficie bidimensionale attraverso un’opportuna
tecnologia di proiezione. Quello che forse non tutti sanno sugli ologrammi è
che, se li dividiamo in due, ogni metà è in grado di ricreare l’intera figura,
un po’ come quando una lucertola perde la coda.
Questo accade perché gli
ologrammi sono costituiti da “pixel” ognuno dei quali contiene l’intera
informazione relativa all’intera figura. Ciò che caratterizza maggiormente un
ologramma è proprio il fatto che tutta informazione di una figura
tridimensionale può essere interamente contenuta in una superficie
bidimensionale.
Se le cose stanno così – ovvero, se un oggetto reale in 3D e
la sua immagine olografica in 2D sono equivalenti dal punto di vista
dell’informazione – come potrebbe una figura in un ologramma “sapere” di essere
bidimensionale e non tridimensionale? Be’, tecnicamente non sarebbe affatto
banale: i due sistemi sarebbero praticamente indistinguibili.
Da qui nasce una domanda piuttosto ardita: e se fossimo noi,
gli ologrammi? O meglio, se il nostro universo fosse in realtà in 2D e noi
percepissimo soltanto un’illusione della tridimensionalità? Questa può sembrare
una domanda filosofica, o tutt’al più fantascientifica, ma ha catturato
l’attenzione di eminenti fisici teorici come il premio Nobel Gerardus ’t
Hooft e Leonard Susskind, che nel contesto della teoria delle
stringhe hanno formulato il cosiddetto principio olografico,
una congettura secondo cui la descrizione fisica di un dato universo a n
dimensioni sarebbe equivalente a quella di un universo a n – 1
dimensioni opportunamente scelto sul “bordo” del primo.
Secondo il principio olografico, potremmo benissimo trovarci
in un’universo in due dimensioni spaziali, in cui la percezione della terza
comparirebbe soltanto su larga scala e nel limite delle basse energie.
Insomma, la questione rientra a pieno titolo nella scienza
“ufficiale” e merita senz’altro un’approfondimento, se non altro per l’enorme
portata che avrebbe una scoperta in questo senso. Fortunatamente, l’ingegno dei
fisici ha trovato un possibile modo per stabilire se l’universo è
tridimensionale come ci appare o se la terza dimensione è soltanto una nostra
percezione e non fa parte della struttura fondamentale della natura.
Proprio per rispondere a queste domande ha preso il via nei
giorni scorsi un ambizioso esperimento al Fermilab, il laboratorio di fisica
delle particelle nei pressi di Chicago. Lì è stato realizzato un
“interferometro olografico”, o più brevemente olometro, un complesso strumento con cui
si spera di far luce sulla questione. “Se mai dovessimo vedere qualcosa, l’idea di spazio che ci
ha accompagnato per migliaia di anni è destinata a cambiare completamente”,
dichiara Craig Hogan, direttore del Centro per l’astrofisica
particellare al Fermilab e tra i massimi esperti nel settore.
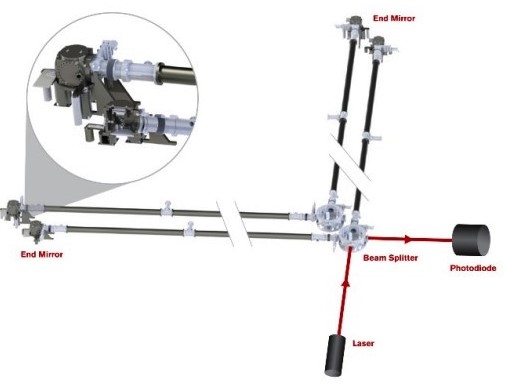
Schema dell’olometro. Con i suoi laser dalla potenza di ben 1 kilowatt, e i bracci lunghi circa 40 metri, è in grado di misurare il rumore olografico, ovvero la “pixelizzazione” dello spazio-tempo, sulla scala del miliardesimo del miliardesimo di metro.
Ma cosa si aspetta di vedere, o non vedere, Hogan? Per
capirlo, torniamo per un istante all’olometro in dotazione al Fermilab. Questo
è costituito da una una coppia di interferometri affiancati, con bracci lunghi
40 metri, funzionanti con fasci di luce laser che ricombinati insieme
dovrebbero produrre un’interferenza dovuta al cosiddetto “rumore olografico”.
Questo affascinante fenomeno, teorizzato dallo stesso Hogan,
si basa sulla considerazione che anche per lo spazio-tempo, oltre che per la
materia, possa valere il principio
di indeterminazione di Heisenberg: in pratica, significa che non si può
determinare con precisione assoluta la posizione di un punto specifico dello
spazio. Da questa “incertezza” intrinseca nella natura ha origine il concetto
di “rumore” olografico.
Se viviamo in un universo in 2D, tutto questo si tradurrebbe
in una “pixelizzazione” della trama dello spazio. Secondo il principio
olografico, quindi, lo spazio(-tempo) non sarebbe un’entità continua ma
discreta, fatta cioè da “pixel” di dimensione finita. Proprio come in un
ologramma, verrebbe da pensare. L’analogia non è affatto casuale, perché in uno
spazio discreto anziché continuo la quantità di informazione immagazzinabile in
un dato volume di spazio sarebbe necessariamente finita (nel senso di non
infinita) e potrebbe essere interamente contenuta nella superficie
bidimensionale che contiene tale volume. Proprio come in un ologramma, appunto.
Il principio olografico permette di calcolare l’intensità di
questo effetto, permettendo un confronto con eventuali misurazioni
dell’interferenza tra i laser dell’olometro. “Se alla fine riusciremo a isolare
un rumore del quale non ci sia modo di sbarazzarsi, potremmo aver rilevato
qualcosa di fondamentale della natura: un rumore intrinseco allo spaziotempo”,
spiega Aaron Chou, fisico responsabile dell’olometro. La cosa non è così
semplice, perché le misure sono assai complesse e sarà estremamente difficile
non farsi ingannare da sorgenti spurie (ovvero non attribuibili univocamente al
rumore olografico), ma tecnicamente possibile.
Se si scovasse il rumore olografico predetto da Hogan
sarebbe dimostrata sperimentalmente la validità del principio olografico.
Questa scoperta sarebbe letteralmente sensazionale: cambierebbe in maniera
radicale il nostro concetto (già messo a dura prova dalla fisica del Novecento)
di che cosa sia lo spazio. “Per la fisica si tratta di un momento emozionante.
Un risultato positivo inaugurerebbe un nuovo modo di interrogarsi su come
funziona lo spazio”, confessa Chou. Per qualunque esito facciate il tifo, non
resta che attendere i primi risultati dal Fermilab.



