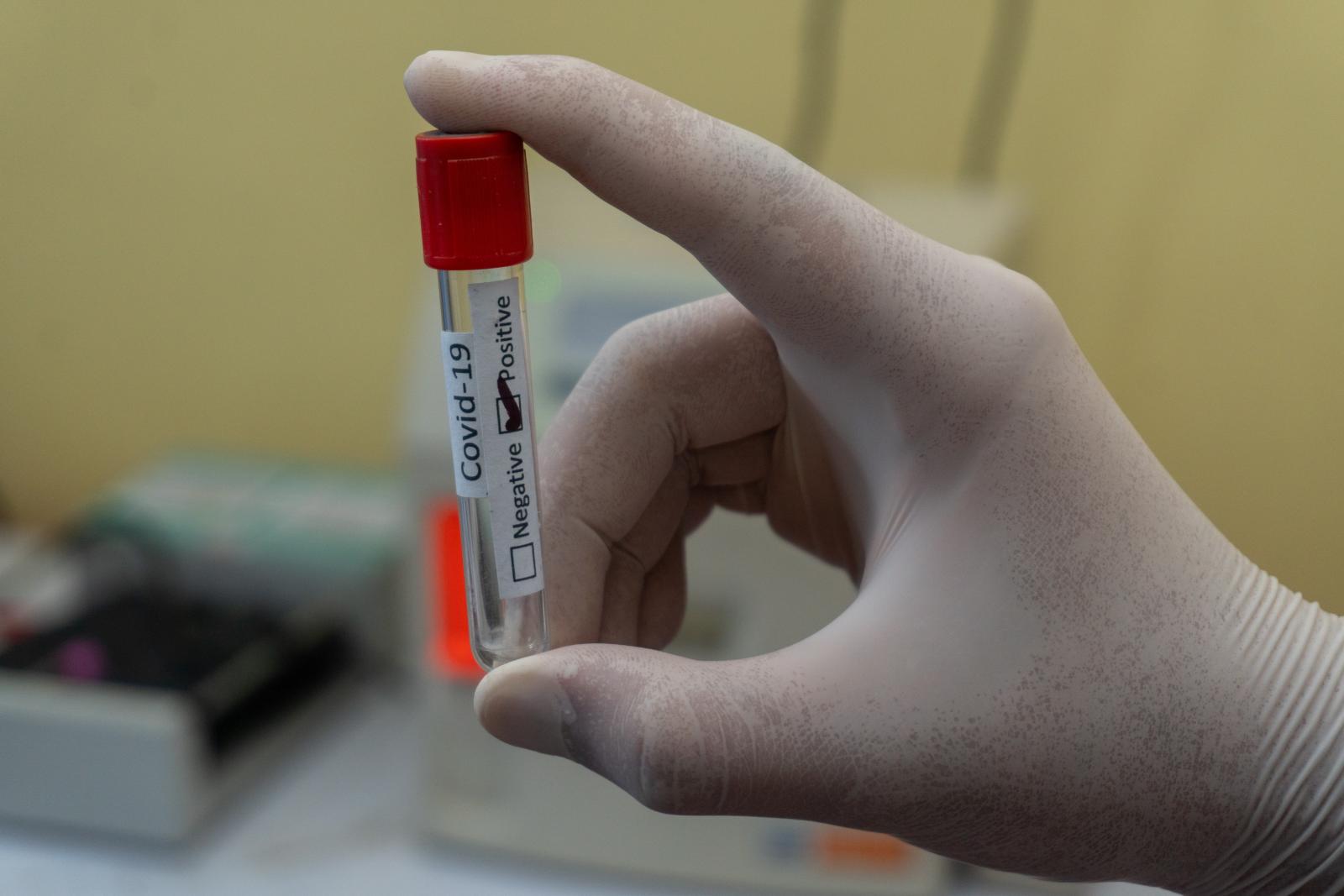
La convivenza con Covid-19 non può ancora affatto dirsi stabilizzata, soprattutto a causa della grande variabilità di SARS-CoV-2. Per questa ragione, mentre il numero di casi in Italia è in aumento, è necessario limitare l'impatto delle infezioni agendo su due fronti, non alternativi tra loro: ridurre la quota delle persone tornate parzialmente suscettibili e limitare le probabilità di emergenza di nuove varianti.
Crediti immagine: Prasesh Shiwakoti (Lomash)/Unsplash
Si è tentato più volte di archiviare Covid-19, cercando di lasciarci alle spalle un’esperienza degna del peggior romanzo distopico (circa 770 milioni di casi registrati ufficialmente in tutto il mondo e circa 18 milioni di decessi stimati), ma a quanto pare la preconizzata “convivenza” con i virus della famiglia non si è ancora stabilizzata e ci vorrà un arco di tempo dell’ordine di diversi anni per arrivarci. L’obiettivo sarà quello di una persistenza endemica con la circolazione virale che si manifesti in andamenti prevedibili, per esempio ciclicità annuali o stagionali, come per i virus influenzali. Al momento la grande incognita è ancora la variabilità dimostrata dal virus Sars-CoV-2, che, pur non essendo maggiore di altri virus già noti, ha ancora troppi punti non chiariti.
All’inizio della pandemia, per i primi otto mesi circa, la presenza di varianti identificate era ancora molto limitata e la previsione di scarsa variabilità virale si è dimostrata completamente errata, dovuta alle limitate circolazione e numero di osservazioni. La rilevanza sanitaria di ogni variante dipende dalla sua trasmissibilità, virulenza e capacità di evadere la nostra risposta immune. Si stima che, fino alla fine del 2021, la diffusione di Alfa e Delta furono soprattutto dovute alla loro elevata trasmissibilità associata a una modesta capacità di immunoevasione, mentre il successo della variante Omicron, che ha sostituito la variante Delta, sembra associato a una maggiore capacità di sfuggire alla nostra risposta immune.
La maggior parte delle infezioni da Sars-CoV-2 causa una malattia acuta che il nostro sistema immunitario risolve nel giro di 10-15 giorni. Dopo il contagio, le particelle virali si riproducono a velocità esponenziale nel tratto respiratorio raggiungendo una massima concentrazione 2-5 giorni dopo l’esposizione al contagio, tempo che corrisponde al momento dell’insorgenza dei sintomi. Questo è più o meno simile per tutte le varianti, ma per Omicron il picco di massima concentrazione virale è di circa tre giorni, tempo durante il quale si può trasmettere efficacemente l’infezione.
Nelle ultime settimane, il numero di casi di Covid-19 segnalati in Italia è in crescita. La media giornaliera dei contagi, che era meno di 500 a metà luglio, all’inizio di settembre ha superato i 3.000, con un picco di 5.547 il 5 settembre. I ricoveri nel giro di un mese sono più che raddoppiati (all’inizio di agosto erano ricoverati solo 812 malati positivi al Covid, mentre al 6 di settembre, i ricoverati sono 1.872). I casi segnalati sono più frequenti tra gli anziani e le cifre riportate sono senz’altro sottostimate, dato il frequente ricorso ai tamponi fatti in proprio e la mancata segnalazione per i soggetti più giovani.
Fare previsioni di come evolverà l’epidemiologia a breve di Covid-19 è difficile, ma è possibile immaginare che l’affievolirsi delle nostre difese immunitarie, già comprovata dal verificarsi di ulteriori infezioni in persone che si sono già ammalate una prima volta (l’ultimo bollettino ISS riporta che il 38% dei nuovi casi segnalati erano già stati infettati precedentemente), e l’emergenza di ceppi virali con nuove caratteristiche antigeniche porteranno a periodiche ondate epidemiche. Per limitare l’impatto delle infezioni si può quindi da una parte agire sulla riduzione della quota delle persone tornate parzialmente suscettibili e dall’altra sulla limitazione delle probabilità di emergenza di nuove varianti. È comunque necessario tenere presente che i due approcci non sono alternativi, dato che le evidenze di efficacia della vaccinazione sono solide per i quadri clinici severi, ma non altrettanto per le infezioni.
Per ridurre la quota di casi che richiedono assistenza sanitaria dovuti alla diminuzione dell’immunità viene proposta una ulteriore vaccinazione. Già nello scorso giugno EMA e ECDC hanno firmato un documento congiunto che indica alle aziende produttrici di formulare nuovi vaccini monovalenti costruiti verso la variante Omicron XBB.1.5, poiché i discendenti del ceppo XBB1 sono predominanti a livello globale.
La dimostrazione di efficacia di questi prodotti è complicata dalla preesistente diffusa parziale immunità e quello che ci si aspetta è un beneficio incrementale, impossibile da dimostrare per le semplici infezioni ma valutabile, con adeguati studi epidemiologici, per i quadri clinici più severi. Le evidenze richieste al momento dell'autorizzazione in commercio sono essenzialmente di laboratorio, basate sulla titolazione degli anticorpi indotti dalla vaccinazione, anche in modelli animali, capaci di neutralizzare diverse varianti di Sars-CoV-2. Come per la vaccinazione stagionale contro l’influenza, la scelta della formulazione dei nuovi vaccini è quella considerata più “ragionevole” prima della stagione invernale. Rispetto all’influenza, tuttavia, abbiamo lo svantaggio della mancanza di una netta stagionalità, che rende impossibile trarre vantaggio dalla conoscenza di quali virus circolino alternativamente nei due emisferi del mondo e siano quindi predittivi delle singole stagioni in ogni emisfero. Il monitoraggio sul campo dell’efficacia vaccinale sarà vitale, anche per capire se la strada intrapresa sarà valida anche per le prossime stagioni.
I nuovi vaccini dovrebbero essere disponibili a breve e una circolare del Ministero della Salute ha già dato indicazioni circa le raccomandazioni ufficiali, molto simili a quelle per la vaccinazione anti-influenzale. La protezione fornita dalle vaccinazioni è individuale, altamente raccomandata per i soggetti a rischio di quadri clinici severi, e l’idea di raggiungere un’immunità di gregge è stata ormai abbandonata completamente. Ma non è auspicabile pensare di lasciar correre le infezioni, a causa del rischio di insorgenza di nuove varianti.
Maggiore è il numero di persone che si infettano, maggiore è il numero di replicazioni virali e maggiore è la probabilità che emergano virus ancora più efficienti nella diffusione e nel causare malattia. Insomma è un circolo vizioso, che impone di mantenere ancora un certo livello di attenzione e di precauzioni per limitare la diffusione e comunque ridurre anche la circolazione di varianti “importate” da identificare tempestivamente.
Smantellare o ridurre la sorveglianza epidemiologica e virale e azzerare l’attenzione della popolazione generale nei confronti della diffusione virale non sembra una strategia adeguata. È invece necessario rinforzare la capacità di identificazione precoce di focolai epidemici e di varianti ad alto rischio (varianti “preoccupanti” come le definisce l’OMS). Durante le prime fasi della pandemia, in assenza di molti dati, è stato fatto largo uso di modelli matematici per stimare i parametri di diffusione e costruire scenari e in base a questi prendere decisioni di sanità pubblica. Ora quegli stessi modelli potrebbero essere ancora più precisi e utili se alimentati da dati reali generati da una buona sorveglianza epidemiologica, dallo studio dei focolai epidemici, delle trasmissioni intrafamiliari per la stima dei tassi di attacco secondari, dallo studio della trasmissibilità, virulenza e capacità di immunoevasione delle diverse varianti circolanti, anche utilizzando la sorveglianza delle acque reflue per identificare e caratterizzare varianti la cui circolazione non è identificata dai casi clinici indagati.
Durante le prime fasi della pandemia abbiamo dovuto accettare l’incertezza di dati incompleti per gli studi in corso e i tempi rapidissimi a cui non eravamo preparati. Ora, non disporre di strumenti per monitorare la circolazione virale, valutare l’impatto delle nuove vaccinazioni e identificare i punti cruciali in cui intervenire sarebbe ingiustificabile.



