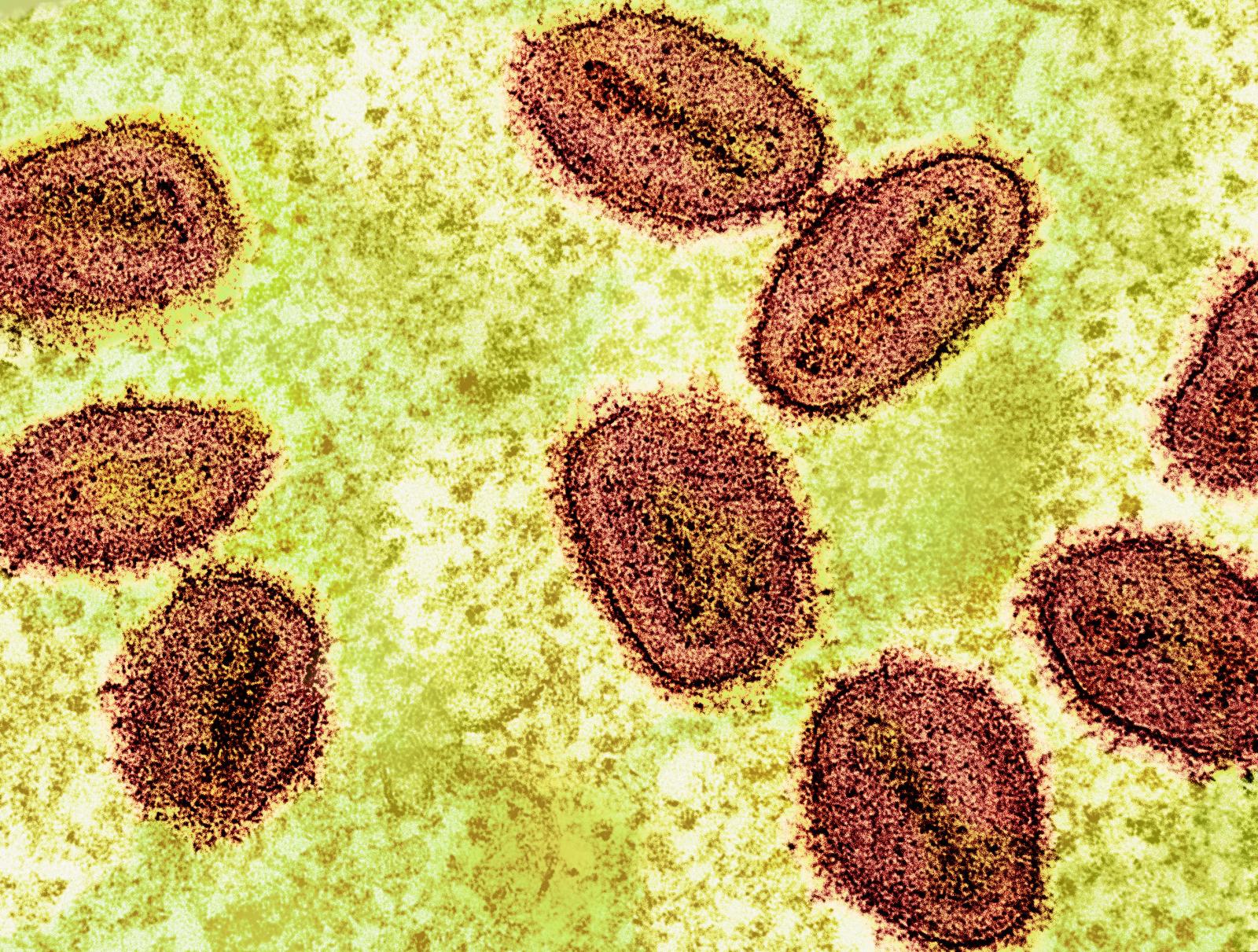Della morte di Cavour e del racconto che ne hanno fatto il Lancet, il British Medical Journal e negli Stati Uniti il New England Journal of Medicine tra il 15 giugno e il 17 agosto del 1861 s’è già scritto (Corriere 23 aprile). E dell’ammirazione incondizionata che emerge da quegli scritti “per l’eroe della libertà e per il letterato che sapeva di scienza”. Allora il Lancet scriveva “il debito dell’Inghilterra verso l’Italia è incalcolabile” e in Inghilterra erano convinti che persino Harvey (quello che ha scoperto che il sangue circola e che ha messo le basi della medicina moderna) non ci sarebbe arrivato mai se non fosse stato a Padova, alla scuola di Fabrizio Acquapendente e di Casserio. Poi però s’è perso tutto. Negli stessi giorni in cui moriva Cavour, lo stato Pontificio, quello stesso che trecento anni prima aveva perseguitato Galileo e che faceva di tutto per opporsi alla scienza, aveva cacciato fuori quindici medici, i migliori. Basta a spiegare il declino della scienza e della medicina in Italia? Probabilmente no, il problema è molto più complesso. L’Italia della prima metà dell’ottocento, paradossalmente più della Gran Bretagna, subisce il fascino di un medico inglese, John Brown, autore di un’opera monumentale “Elementa medicinae”. Sosteneva che la salute era fatta di un equilibrio tra l’essere rilassati ed eccitati e che le malattie erano per troppa eccitazione. Giovanni Rasori di Parma - che fu professore a Milano – ne traduceva tutti i libri. In quel periodo c’era “una eclisse del pensiero medico in Italia, quasi sprofondato nelle sabbie mobili di un dottrinismo sterile nel campo della ricerca e nefasto in quello della pratica, mentre altrove, ad esempio in Francia, Bichat e Laennec non abbandonavano la via tracciata da Morgagni nella quale in Germania, si istradavano Giovanni Muller e Rodolfo Virchow”, così Antonio Cazzaniga nel suo libro “La grande crisi della medicina italiana” dell’inizio del diciannovesimo secolo. Lo stetoscopio di Laennec del 1816 fu il simbolo di una medicina che passava dai pregiudizi all’evidenza: osservazione, esame fisico, valutazione dei tessuti al microscopio. Tutti in Europa abbracciarono queste novità con entusiasmo. In Italia no. La teoria dell’eccitazione sfociava inesorabilmente nel salasso (“se uno è troppo eccitato è perché ha troppo sangue, e allora caviamoglielo fino a che riesce a tollerarlo, e anche di più se serve”), così la prima metà del ‘800 è stato un periodo buio per la scienza. Continue dispute e pratiche obsolete ci hanno tenuto lontani dai circuiti della medicina vera che ormai si praticava in tutta Europa.
In Italia i dottori erano rimasti ciarlatani e la gente se ne rendeva conto. L’Italia era divisa in stati e staterelli retti da re, duchi e granduchi, intolleranti a tutte le novità. I “Congressi degli Scienziati Italiani” che c’erano ogni anno dal 1839 al 1847 avrebbero dovuto essere occasione per discutere di cose mediche e aprirsi alle idee che ormai avevano preso piede all’estero. Il primo di questi congressi, quello del 1839 lo fecero a Pisa e il Papa Gregorio XVI spaventato all’idea che questo diventasse un congresso di liberali e sovversivi impedì a Carlo Matteucci di prendervi parte. Dovette invece comparire davanti alla Santa Inquisizione dove gli fecero un sacco di domande prima che potesse pubblicare uno dei suoi libri di fisiologia. Le conseguenze di quel brutto periodo si sono fatte sentire e forse ne risentiamo anche oggi. Qualche esempio?
Dal 1930 al 1960 in medicina è successo di tutto. La scoperta del primo sulfamidico è del ‘32, il pentothal fu usato per la prima volta in anestesia nel ’34 e questa scoperta ha coinciso con l’esplosione della chirurgia. La scoperta della struttura del DNA è del ’53, i primi vaccini sono comparsi nel ’54, il primo tentativo di dialisi è del ’56, i primi interventi a cuore aperto del ‘60. Qual è stato il contributo degli italiani? Quasi niente con una importante eccezione la scoperta della doxorubicina, il primo farmaco anticancro nel 1960. Merito di Farmitalia-Carlo Erba. Poi più nulla. Gli industriali del farmaco non hanno saputo mettersi insieme e i politici non hanno capito che questo era un settore cruciale. Gli italiani che hanno avuto il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia sono stati solo sei ma quattro di loro (Salvador Luria, Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini e Mario Capecchi) lavoravano negli Stati Uniti. Le ragioni sono tante e in parte ben note, abbiamo meno ricercatori di tutti, degli Stati Uniti, del Giappone, di tutti gli altri paesi d’Europa. Investiamo in ricerca un terzo di quello che investono gli Stati Uniti, il Giappone e la metà di Francia, Germania e Regno Unito. La distribuzione dei fondi pubblici è ancora oggi viziata da procedure non trasparenti. Nelle liste delle prime università del London Times di Istituzioni italiane non ce n’è nemmeno una, peccato perché oggi l’Italia ha scienziati di prim’ordine in tutte le discipline.
Se uno guarda Thomson’s Scientific Essential Science Indicator che raccoglie e giudica la produzione scientifica e fa una graduatoria in base a quanto sono citati da altri i lavori degli italiani vede che su 106 paesi siamo al dodicesimo posto e secondo World Health Report of the Year dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2000 eravamo secondi solo alla Francia per qualità delle prestazioni del nostro Servizio Sanitario Nazionale.
E poi c’è la politica. Sempre, prima delle elezioni, si sente dire che ci saranno più soldi per la ricerca, che si riformeranno le Università, che i ricercatori migliori e i medici migliori potranno avere una carriera accademica anche da noi. Tutte promesse che svaniscono regolarmente qualche settimana dopo. C’è sempre qualcosa di più urgente. Negli ultimi quindici anni abbiamo avuto governi di destra e di centro sinistra ma di qua e di là c’è chi è contro la scienza per principio o per convinzioni religiose. Lo si è visto per la fecondazione assistita, la ricerca sulle cellule staminali e le decisioni di fine vita. La legge 40 del 2004 che regola la fecondazione assistita è in contrasto con le regole della medicina e col buonsenso. Per la nostra legge non si possono produrre più di tre embrioni per volta e li si devono trasferire tutti e tre nell’utero della madre. La fecondazione assistita funziona nel trenta percento dei casi e con tre embrioni soltanto la percentuale è ancora più bassa. E allora serve un altro ciclo di stimolazione ormonale, che ha dei rischi, e un nuovo intervento chirurgico per avere gli oociti. C’è anche il caso che vada tutto bene, e allora saranno tre gemelli. Ma le probabilità che uno o due sia ammalato o muoia è alta, e anche la mamma corre qualche rischio. La legge dice che è vietata qualsiasi forma di selezione degli embrioni. Anche questo è in contrasto con i principi della medicina. Se uno dei genitori è portatore di anomalie genetiche, si vorrebbe evitare di trasmetterle ai figli. Ma da noi non si può. Gli embrioni che vengono dalla fecondazione in vitro, vanno messi tutti nell’utero, così come sono. Se mai si abortirà dopo. E non si può ricorrere al seme di un altro. Certe volte però un donatore servirebbe, o per la cattiva qualità del seme del partner o perché non ci sono abbastanza spermatozoi. Dal momento che questi limiti non ci sono in Francia, Regno Unito, Spagna, Grecia e Belgio gli italiani vanno all’estero.
Lo stesso per la ricerca con le cellule staminali embrionali. Le possiamo usare ma non le possiamo produrre nemmeno da embrioni che se no si butterebbero via. Chi ci lavora, le cellule le va a prendere all’estero. Intanto chi è contro continua a sostenere che di cellule embrionali, non ce n’è bisogno, si può far tutto con le cellule adulte. Ma questo non è vero. Anche le disposizioni di fine vita e i diritti dell’individuo sono da noi materia di scontro politico. Entrare nel merito di questioni così delicate importa poco. L’importante è compiacere gli elettori, se questo va contro le regole della medicina che sono le stesse in qualunque parte del mondo pazienza. Dagli Stati Uniti all’Europa, al Giappone, all’Australia e sempre di più anche nei paesi emergenti fare il medico è rianimare, ma anche saper sospendere le cure quando sono inutili. Fa parte delle nostre responsabilità. E’ a tutela di chi non ha più speranza perché non debba subire trattamenti inappropriati - alimentazione e idratazione aiutano a guarire ma ci sono casi in cui farlo aumenta le sofferenze anziché alleviarle.