
Wisława Szymborska, 1923-2012 (Fot. Scanpix/Forum).
Ci sono domande che, pur non formulate esplicitamente, sottendono l’opera di Wisława Szymborska, poetessa polacca amatissima anche in Italia e premio Nobel per la letteratura. Come guardare al mondo? Come entrare in contatto col mondo, come descriverlo? Sono le stesse domande alle quali, da tanti secoli, cerca di rispondere, accanto alla poesia, anche la scienza. Ma la poesia e la scienza guardano al mondo allo stesso modo?
Lo stupore
Una caratteristica della poesia, della sua poesia, che Wisława sottolinea più volte, è quella dello stupore. Lo stupore che da lei è sentito quasi come un dovere morale, fino ad affermare, come nel testo poetico Disattenzione,
Ieri mi sono comportata male nel cosmo,
ho passato tutto il giorno senza fare domande,
senza stupirmi di niente.
O anche, in una riflessione poetica sul ruolo del caso nella storia naturale (Nella moltitudine),
Sono quella che sono
Un caso inconcepibile
come ogni caso [...]
Potevo essere me stessa – ma senza stupore,
e ciò vorrebbe dire
qualcuno di totalmente diverso.

Lo stupore, certo, è anche all’origine della scienza, è ciò che spinge a conoscere, a capire. Eppure, a volte sembra che si sia perduto per strada. Forse, ipotizza ironicamente la poetessa, per mancanza di tempo? Nella poesia Eccesso incontriamo questi versi:
Lo stupirsi non sarebbe qui affatto strano
se solo ne avessimo il tempo.
La poesia parla della scoperta di una nuova stella da parte degli astronomi, da parte – così vengono definiti non senza ironia – degli “ambienti vicini al cielo”. La stella è stata scientificamente classificata: è una stella tra le altre, definita da numeri, incasellata da numeri che agli scienziati sembrano dire tutto su di essa. E’ una stella “lontana, tanto lontana da essere piccola”, è una tra le tante.
C’è forse nel cielo un eccesso di stelle? Questo sembra suggerire il titolo della poesia. Una miriade di stelle sotto cui “nasce l’uomo” e “dopo un attimo muore”. Quante domande potrebbero nascere dalla contemplazione di quella stella, proprio di quella, che è lì, “tra l’orlo della nuvoletta bigia sfilacciata e quel rametto, più a sinistra, di acacia”. Tante domande potrebbero nascere sulle stelle, sulla loro impassibile relazione con noi, sui nostri brevi attimi sotto il loro sguardo. Invece, negli “ambienti vicini al cielo”, si brinda “masticando noccioline”! Si brinda alla tesi di dottorato dedicata alla scoperta della stella, alla sua descrizione scientifica (età, massa, posizione), e soprattutto alle signore presenti, assai più vicine della stella.
Risuona Leopardi
“A che tante facelle?”, cantava dolente il pastore errante immaginato da Giacomo Leopardi. E, leggendo questa poesia, viene fatto di ripensare a quella domanda, pur notando il clima assai diverso, meno sofferto, più leggero, e soprattutto ricco di una amabile ironia così szymborskiana. La dolente assenza di risposta alla domanda di Giacomo di fronte all’eccesso di stelle diventa, in Wisława, una attenzione a cercare quella singola stella, a guardarla con stupore, a immaginare una relazione con lei.
La stella nuova, a quanto pare, non ha influenza sulle mode, sull’esito dei match, e sulla laccatura del tavolo delle trattative: su tutto ciò che riempie i nostri “giorni contati della vita”. Questo fa pensare a un capitoletto di quel delizioso libro che è Letture facoltative, dove Wisława raccoglie un ampio gruppo di recensioni anche di opere di divulgazione scientifica, opere che – ha affermato – le erano simpatiche, perché “non finiscono né bene né male” . In una di queste si parla di un libro di statistica, su cui l’autrice ironizza come su nessun altro ambito scientifico. “Ogni volta che provo a tradurre le cifre in una immagine” – afferma – “mi compare davanti agli occhi un uomo tutto intero cui spetta una donna tutt’intera più qualche decimo. Quella strana coppia mette al mondo due figli (approssimativamente) e i loro bambini all’istante prendono a bere alcol puro, cosicché in un anno ne avranno già consumato quattro litri e mezzo...”.
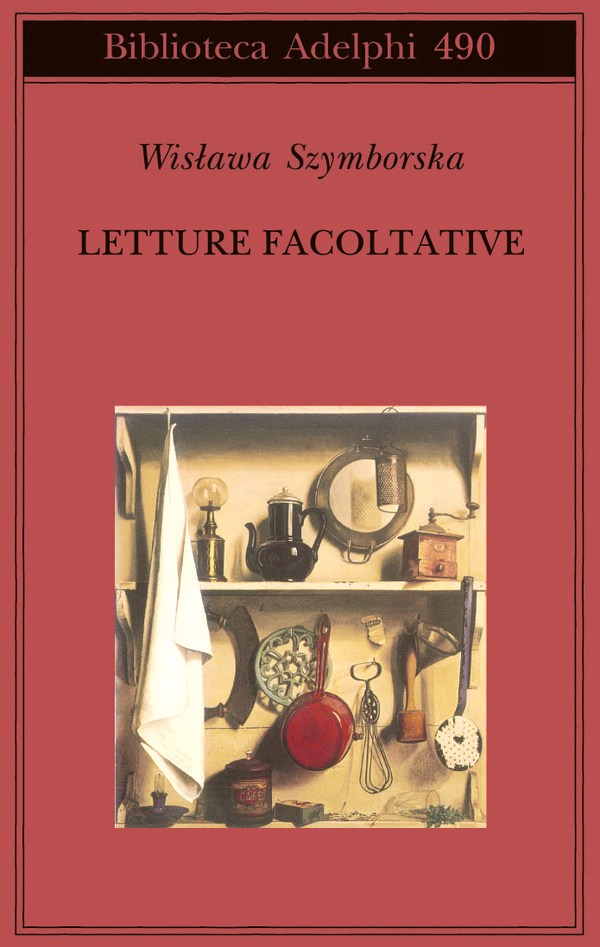
Ancora una volta queste frasi richiamano Giacomo Leopardi, quando nella Palinodia al Marchese Gino Capponi (1834-1836) ironizza sulla tendenza della statistica - la scienza del secolo nuovo, delle “magnifiche sorti e progressive” - a quantificare, a ridurre, ad appiattire in numeri comportamenti e abitudini:
[...] e imprenderà col latte
Della cara nutrice ogni fanciullo,
Quanto peso di sal, quanto di carni,
E quante moggia di farina inghiotta
Il patrio borgo in ciascun mese [...]”.
Vade retro statistica
Ma, perché Wisława Szymborska ha una particolare insofferenza (pur sempre leggera e sorridente) nei riguardi della statistica? Si capisce già dai brevi cenni appena citati: perché al massimo grado essa si allontana dal particolare, dall’individuale, dall’osservazione minuta della vita per aspirare a valori generali e astratti, a tendenze, a leggi. Il che è tanto più problematico quando oggetto dello studio scientifico sono non le stelle, ma le persone. E la sua deliziosa ironia la porta a dare, nientemeno, un Contributo alla statistica con una poesia che porta appunto questo titolo.
Su cento persone:
che ne sanno sempre più degli altri
- cinquantadue;
insicuri a ogni passo - quasi tutti gli altri”.
E così via, fino a concludere:
Mortali - cento su cento.
Numero al momento invariato.
Obiettivo più o meno esplicito della scienza è quello di guardare il mondo da lontano, dal di fuori, come se anche noi non ne facessimo parte. Questo, ci dice Wisława in un’altra poesia, non solo è impossibile, ma “E’ una gran fortuna” (questo il titolo della poesia) che sia così. Infatti “da questa prospettiva” – dalla prospettiva che guarda il mondo da lontano, come fa la statistica – “addio per sempre particolari ed episodi!” I particolari e gli episodi, appunto, che sono per lei ciò che conta veramente.
Un gioco con regole ignote
Fare domande e stupirsi: questo il nostro compito quotidiano, richiamato nella poesia Disattenzione che ho prima citato. Avere un pensiero che vada “più in là dell’uscire di casa e del tornarmene a casa”. Non è solo la scienza, dunque, a rischiare un problematico allontanamento dal particolare andando verso un mondo di numeri, verso quella che viene definita in E’ una gran fortuna una “chiarezza della visione e di conclusioni definitive” : è anche il nostro atteggiamento di tutti i giorni, che ci porta a svolgere “attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto”. Senza accorgerci che intanto il mondo cambia, “perfino nell’ambito ristretto di un batter d’occhio”, e che quindi tanto più il nostro sguardo dovrebbe essere attento, le nostre domande più profonde. E invece, questa profondità ci manca, come a “un chiodo piantato troppo in superficie nel muro, oppure (e qui un paragone che mi è mancato)”. Dovremo imparare a vivere, dovremmo mantenere sempre “una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote”. Splendida, questa frase: programma di vita non solo per un poeta, ma forse anche per uno scienziato, che cerca di scoprire alcune di queste regole del gioco. Mantenere lo stupore davanti al mondo è anche il punto di partenza per capirlo meglio, spostando un po’ più in là le domande a cui non sappiamo rispondere.
Newton e Curie, che non sapevano

Nel discorso tenuto in occasione del Premio Nobel, nel 1996, Wisława Szymborska cita con ammirazione due scienziati: uno scienziato del passato, Isaac Newton, e una scienziata moderna sua connazionale, Maria Skłodowska, più conosciuta come Maria Curie. E li cita proprio per la loro curiosità, per le loro domande. Cita Isaac Newton perché “se non si fosse detto non so, le mele nel giardino sarebbero potute cadere davanti ai suoi occhi come grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle, mangiandole con gusto”. E lo cita, come abbiamo sentito, con una ammirazione non disgiunta, al solito, da una nota scherzosa. Ma cita anche Maria, la grande Maria, che ben due volte prima di lei si è recata a Stoccolma per ricevere il premio Nobel. E questo perché si è fermata a guardare con stupore il comportamento di un umile sale di Uranio, e non ha capito, e ha detto non so, e ha lavorato anni per capire, e finalmente ha dato un nome, Polonio, in omaggio alla sua patria, al protagonista (insieme al Radio) di quella piccola storia divenuta poi grande. “Se la mia connazionale Maria Skłodowska Curie non si fosse detta non so sarebbe sicuramente diventata insegnante di chimica per un convitto di signorine di buona famiglia, e avrebbe trascorso la vita svolgendo questa attività, peraltro onesta”.
“Anche il poeta”, conclude Wisława, “deve ripetere di continuo a se stesso non so”. E deve fare domande. Domande al mondo, a tutto il mondo a cui nella sua umanità è intimamente legato, perché l’uomo – come ci propone la poesia Uno spasso, è “un misero figlio degenerato del cristallo”. Questa tra uomo e cristallo è una connessione che può apparire sorprendente, ma che già era già stata intuita da uno scienziato poeta come Erwin Schrödinger, uno dei fondatori della meccanica quantistica, che in un suo libretto del 1944 destinato a fare epoca, intitolato Che cos’è la vita?, si chiedeva se il misterioso DNA non potesse avere la struttura di un cristallo aperiodico (come Crick e Watson scoprirono alcuni anni dopo, nel 1951). Una connessione intuita anche da un poeta appassionato di scienza, Raymond Queneau, il quale nella sua Piccola cosmologia portatile del 1944 canta la forza dirompente dei cristalli e insieme il loro ordine strutturale, che sarà anche all’origine dei viventi (“laboriosi orologiai” che lanciano “spermi esatti”). Figlio del cristallo è anche il poeta, che può quindi osare domande ai cristalli, alle pietre, sentendoli vicini a sé: può osare una Conversazione con una pietra.
L'io e la pietra
L’io, in prima persona, bussa più volte (addirittura sei!) a quella che ritiene sia la porta di una pietra: quella pietra, proprio quella, nella sua unicità. E ogni volta usa argomenti diversi per convincerla ad aprirsi, a farlo entrare. A farlo venire dentro, a permettergli di respirarla come l’aria: dunque a entrare nella pietra ma anche a farla entrare dentro di sé, a farla diventare parte di sé. Poi è la mortalità, il poco tempo a disposizione l’argomento che dovrebbe commuovere la pietra: la mortalità di chi vorrebbe in seguito visitare anche “la foglia e la goccia d’acqua”. Ma la pietra – incalza l’io – conosce veramente se stessa? Le sue belle e grandi sale vuote? Non sarebbe, questo ingresso, un’occasione preziosa anche per la pietra, per conoscersi meglio? Non è un intento predatorio quello che muove l’io a conoscere la pietra! L’io promette infatti che, uscendo, porterà con sé solo parole. Di nuovo implora di non farlo aspettare troppo, addirittura “duemila secoli”: non può resistere tanto a lungo. E dopo tutti questi argomenti, resta solo la nuda implorazione che accompagna la presentazione della propria identità: “sono io, fammi entrare”. Tu sei la pietra che voglio conoscere, io sono chi ti vuole conoscere.
Ma, appunto, la risposta della pietra è raggelante. L’io può, sì, conoscerla, ma solo in superficie, mai a fondo: può conoscerla solo fin dove possono arrivare i suoi “poveri sensi”. Solo – sembra di poter dire - fin dove può arrivare la conoscenza scientifica, quella conoscenza che della stella nuova identificava soltanto età, massa e posizione. Ma forse, come afferma la pietra, solo la sua superficie era rivolta verso l’uomo, mentre tutto il suo interno “era girato altrove”. Lo scienziato non se ne è accorto, solo il poeta ha un barlume di consapevolezza di questa chiusura. All’uomo “manca il senso del partecipare”, e il poeta ha appena “un senso di quel senso”. All’uomo, insomma, manca l’empatia, e per questo egli non potrà mai veramente entrare nella pietra, come non potrà entrare nella goccia d’acqua o nella foglia. Non potrà mai conoscere queste realtà dall’interno: la porta per entrare nemmeno esiste, se non nella sua fantasia.
E non c’è nemmeno, da parte del mondo, il desiderio di conoscere lei, la poetessa, che fa domande, che vuol sapere. Malinconicamente, Wisława dovrà concludere (come nella poesia Il silenzio delle piante) che la sua “curiosità non è reciproca”.
Scienza e poesia, conoscenze diverse
La scienza, dunque, emerge da questa poesia come un’attività rassegnata a non poter accedere a una conoscenza più profonda: un’attività che guarda il mondo dall’esterno e, guardandolo, cerca di scoprire le leggi generali a cui il mondo ciecamente obbedisce. Così facendo, la scienza parla una lingua che non è quella del mondo. Ce lo ricorda la poesia Vista con granello di sabbia:
Lo chiamiamo granello di sabbia.
Ma lui non chiama se stesso né granello né sabbia.
Fa a meno di un nome / generale, individuale,
permanente, temporaneo,
scorretto o corretto.
E ancora:
Passa un secondo.
Un altro secondo.
Un terzo secondo.
Tre secondi, però solo nostri.
Lo stupore della poetessa non è rivolto alle leggi che regolano il mondo, ma piuttosto ai singoli eventi, nei quali il caso gioca un ruolo centrale. E anche alla catena di questi eventi, alla immensa catena che costituisce la storia del mondo e dell’umanità. Come nella poesia Attimo, in cui, camminando “sul pendio di una collina verde”, Wisława si stupisce che la vista si distenda:
in silenzio sui colli intorno.
Come se qui mai ci fossero stati cambriano e siluriano,
rocce ringhianti l’una all’altra,
abissi gonfiati,
notti fiammeggianti
e giorni nei turbini dell’oscurità.
E che dire della storia dell’umanità, una incredibile e forse casuale vicenda di perdite continue? Ne parla con l’abituale leggerezza la poesia Discorso all’ufficio oggetti smarriti, dove lo smarrimento dell’ombrello è l’occasione per riandare a ben altre perdite:
Non so neanche dove mai ho lasciato gli artigli,
chi gira nella mia pelliccia, chi abita il mio guscio.
[...] Mi stupisco io stessa del poco di me che è restato.
Voglia di verità
Ma, a valle di tutte queste perdite, che spasso! E’ veramente Uno spasso vedere che
Gli è venuta voglia di felicità,
gli è venuta voglia di verità,
gli è venuta voglia di eternità,
guardatelo un po’!
[...] Con quell’anello al naso, la toga, il maglione.
Uno spasso, comunque.
Un poverino qualunque.
Un vero uomo.
Come può questo “poverino qualunque” conoscere il mondo, quel mondo che non cessa di stupirlo? C’è una interiorità inaccessibile delle cose che i bambini intuiscono quando si costruiscono un’immagine del mondo e degli oggetti che lo popolano. E’ l’immagine di un mondo vivente: di un mondo in cui ogni oggetto ha desideri e volontà, ma anche limitazioni, vincoli, catene. E’quell’immagine che Jean Piaget ha approfonditamente studiato, descrivendone gli sviluppi nel bambino e nell’adulto e fondando così una branca della psicologia, l’epistemologia genetica.
L'esperimento della bimbetta che tira la tovaglia
Ma può accadere, e a volte accade (come nel caso di Wisława Szymborska) che un poeta intuisca in un attimo ciò che uno scienziato come Piaget impiega anni a capire. Lo vediamo nella poesia che si intitola appunto Una bimbetta tira la tovaglia. Questo gesto, per il quale certamente la bimbetta verrà sgridata e forse anche punita, è un gesto scientifico che nasce da una precisa epistemologia, da una precisa filosofia della scienza, che il poeta è in grado di comunicarci per conto della bimbetta. Il mondo – anche il mondo degli oggetti che gli adulti definiscono inanimati, come la pietra della poesia precedente, ma anche come la tovaglia, i bicchieri, i piattini - il mondo, dunque, è percorso da fremiti, da desideri, da volontà trattenute da vincoli. Solo alcuni oggetti, come i muri, gli armadi, il tavolo appaiono più smorti, meno desiderosi di avventure.
Ma la tovaglia sul tavolo ostinato
- se afferrata bene per gli orli -
manifesta già la volontà di viaggiare.
Se questa è l’immagine del mondo, se alla bambina sembra di entrare in contatto con questi fremiti e con questi desideri, perché non aiutare gli oggetti a realizzarli? E così si capirà meglio anche quali erano:
E’ interessante,
quale movimento sceglieranno
quando ormai vacilleranno sul bordo:
un viaggio lungo il soffitto?
un volo intorno alla lampada?
un salto sul davanzale e di lì sull’albero?
La bimbetta, dunque, si accinge a compiere un esperimento scientifico. Da scienziata in erba, è una piccola collega del grande Isaac Newton. Che però non è d’accordo, e vuole fermarla. Ma come? Proprio lui che ha dedicato il suo tempo a studiare come vola nell’aria una mela, una umile mela che si stacca dal ramo? Proprio lui che, dopo tanto sforzo e tanto successo (aveva scoperto nientemeno che la legge di gravitazione universale!), a chi gli chiedeva il perché di tutto questo, che cosa c’era dietro quella che lui chiamava forza (e, fra parentesi, anche lui, parlando di forza, non era meno antropomorfo della bimbetta!) rispondeva: Non lo so. Non faccio ipotesi. Non so. Lo diceva in latino, Hypoteses non fingo, ma diceva proprio quello che pensa la bimbetta.
Il signor Newton non ha ancora nulla a che fare con questo.
Guardi pure dal cielo e agiti le braccia.
Questo esperimento deve essere fatto.
E lo sarà.
Così conclude autorevolmente Wisława, che dà voce a quella bimbetta che tira la tovaglia, e forse anche alla bimbetta che c’è in ognuno di noi.
Pensare con leggerezza

E così, la piccola scienziata ha fatto il suo esperimento. Deve avere avuto un bravo maestro, per arrivare a questo. Un maestro come quello che incontriamo in un’altra poesia, Intervista a un bambino. Un maestro che:
respinge con disgusto l’assurdo pensiero
che un tavolo perso di vista debba restare un tavolo,
che una sedia alle sue spalle stia nei confini di una sedia.
Un maestro con la M maiuscola, che non esita a prendere sul serio i pensieri di tanti anni prima del reverendo George Berkeley, e invita almeno per un po’ i suoi allievi a fare lo stesso. A fare esperimenti, e a pensare. Ma soprattutto, a pensare con leggerezza!


