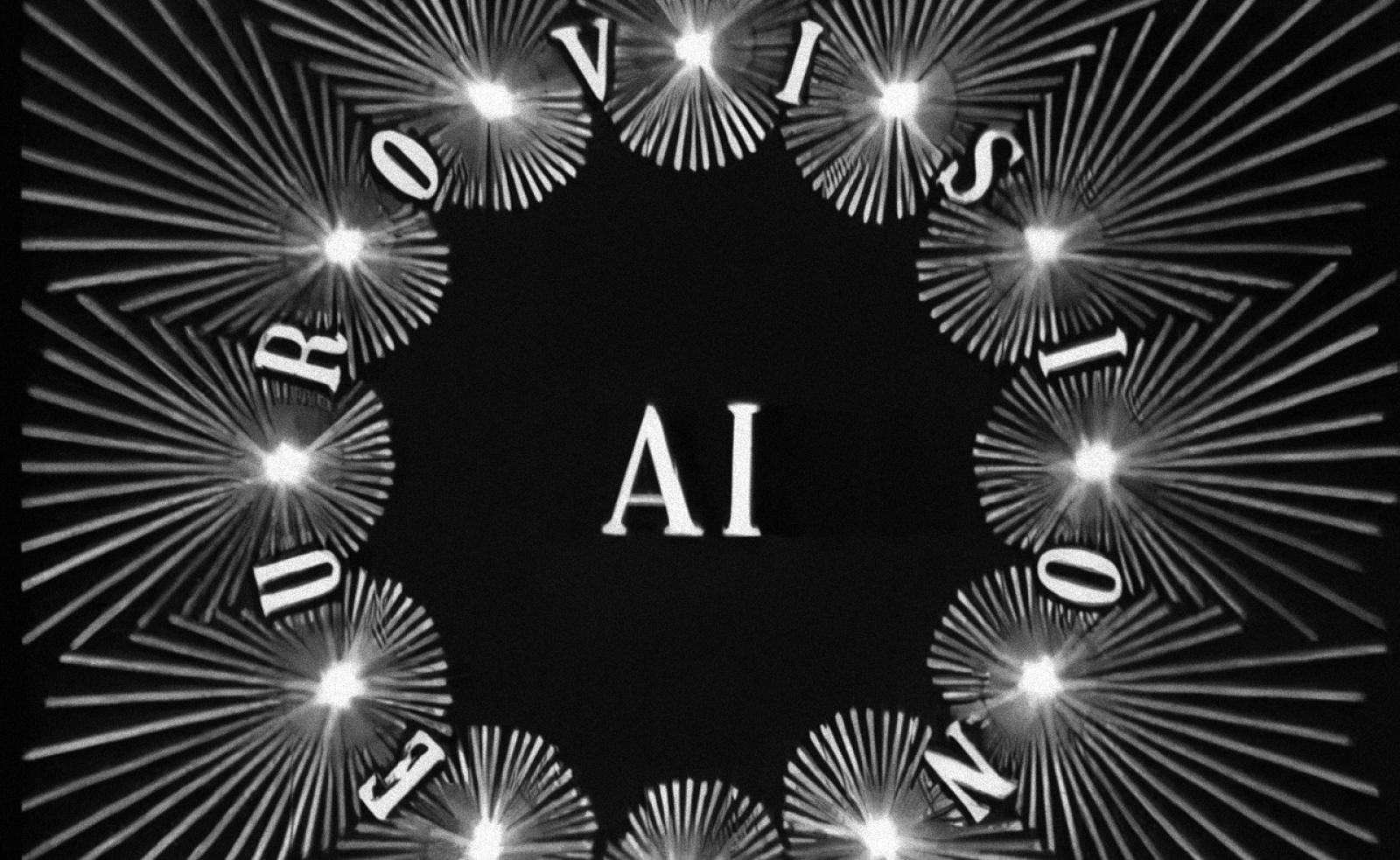Mercoledì la Commissione Europea ha proposto l'istituzione di un "certificato verde digitale" da rilasciare a coloro che sono guariti dall'infezione con SARS-CoV-2 non più di sei mesi prima, oppure sono vaccinati oppure sono risultati negativi a un test diagnostico, RT-PCR o rapido. Chi è in possesso del certificato sarà esentato dalla quarantena all'arrivo in un paese membro dell'Unione, per il resto dovrà osservare le stesse misure di distanziamento di chi non lo possiede. Non si tratta né di un passaporto di immunità né di un passaporto vaccinale, proposte che erano state già fatte in passato ricevendo molte critiche per via della scarsa fondatezza scientifica (le tante incognite sulla durata e il tipo di immunità indotta dall'infezione e dalla vaccinazione) e per i risvolti etici. Tuttavia alcune di queste obiezioni si applicano anche al certificato proposto e sono da tenere in considerazione. Gli Stati membri si pronunceranno nei prossimi giorni. Credit: Piqsels.
Cercai invano un posto da contabile. Nel mese di giugno le attività commerciali si fermavano in quella regione. Tutti quelli che potevano permetterselo, lasciavano quel cimitero di febbre gialla. Assumere un giovane non acclimatato sarebbe stata una pessima decisione: o sarebbe morto oppure, molto probabilmente, lo avrebbe colpito una malattia devastante.
Così scriveva l’immigrato tedesco Gustav Dresel nel diario “Houston Journal: Adventures in North America and Texas, 1837-1841” riguardo ai suoi vani tentativi di trovare lavoro a New Orleans alla fine degli anni ’30 dell’Ottocento senza essere “acclimatato”, cioè senza essere sopravvissuto alla febbre gialla. Essere o meno acclimatati in quel periodo voleva dire trovare o non trovare lavoro, sposarsi o no e, per gli schiavi, valere di più o di meno. Come ha scritto la storica di Stanford Kathryn Olivarius quasi un anno fa sul New York Times, la richiesta di immunità alla febbre gialla non creò le disuguaglianze nella New Orleans di quel periodo, ma di certo le esasperò, spingendo addirittura alcuni a cercare di ammalarsi affollando abitazioni anguste, o saltando nel letto dove qualcuno era appena morto per via dell’infezione.
Le parole di Olivarius, sollecitate dal dibattito nato all’inizio della pandemia di COVID-19 riguardo la possibilità di istituire dei passaporti di immunità, ritornano interessanti in questi giorni.
Mercoledì la Commissione Europea ha proposto l’istituzione di un “certificato verde digitale” che permetta di spostarsi tra gli stati membri dell’Unione senza rispettare la quarantena all’arrivo. Il certificato potrà essere ottenuto dimostrando di cadere in uno tra questi tre casi: aver contratto il virus non più di sei mesi prima ed essere guariti, essere stati vaccinati oppure aver ottenuto un risultato negativo sottoponendosi a un test diagnostico (RT-PCR o antigenico rapido).
La proposta è ora sottoposta alla valutazione dei governi nazionali che dovranno decidere nel giro di pochi giorni.
Il commissario alla giustizia Didier Reynders ha sottolineato che non si tratterà di un passaporto, ma solo di un certificato per garantire un sistema comune che regoli gli spostamenti tra gli stati.
La speranza della Commissione è che il certificato sia funzionante per l’estate in modo da evitare che i paesi la cui economia conta di più sul turismo stringano accordi individuali. La Grecia ad esempio aveva già avviato nelle scorse settimane un dialogo con il Regno Unito per permettere ai cittadini britannici vaccinati di trascorrere lì le vacanze evitando la quarantena all’arrivo.
Il certificato sarà rilasciato non solo ai cittadini europei ma anche a coloro che risiedono nell’Unione e rappresenta una misura temporanea fino a quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità non dichiarerà finita l’emergenza sanitaria in corso.
Riguardo ai vaccini, la Commissione ha dichiarato che saranno accettabili solo vaccinazioni con i vaccini autorizzati dalla European Medicines Agency, ma che gli stati membri potranno decidere di rilasciare il certificato anche a coloro che hanno ricevuto altri vaccini, come Sputnik V o Sinovac, che sono stati autorizzati autonomamente da alcuni paesi dell’Unione.
Ma quanto sono forti le conoscenze scientifiche a sostegno dell’istituzione di questo tipo di certificato? Quali i risvolti etici?
Le risposte a queste domande possono essere informate in parte dal dibattito nato intorno ai passaporti di immunità prima e a quelli vaccinali più recentemente. Israele, molto avanti nell’immunizzazione, ha infatti istituito un “green pass” della durata di sei mesi che viene rilasciato a una settimana dalla seconda dose oppure documentando la guarigione dalla malattia. Coloro che sono in possesso del pass hanno accesso a palestre, cinema, bar e ristoranti, non devono isolarsi se sono entrati in contatto con una persona contagiata né al rientro da viaggi internazionali. Oltre a dare slancio all’economia, la speranza è che il pass favorisca l’adesione alla vaccinazione anche tra quei gruppi che sono meno a rischio di sviluppare forme gravi della malattia.
La fondatezza scientifica
Sia i passaporti di immunità che quelli vaccinali hanno fatto storcere il naso a molti immunologi.
In un editoriale pubblicato su Lancet all’inizio di marzo, si legge infatti che per la COVID-19 non sono ancora noti i cosiddetti “correlati dell’immunità”, ovvero quell’insieme di segnali biologici verificabili con esami diagnostici che garantiscono un buon grado di protezione dalla malattia.
Questo rende poco attraente l’idea, ad esempio, di utilizzare i test sierologici per rilasciare un certificato di immunità. Tra l’altro i test sierologici soffrono di un problema di affidabilità soprattutto in popolazioni a bassa prevalenza dell’infezione, come avevamo spiegato qui. Infatti, in quei contesti, anche test con alti livelli di specificità possono generare un grande numero di falsi positivi.
Per evitare questi problemi, i firmatari dell’editoriale di Lancet suggeriscono di rilasciare il passaporto di immunità sulla base di un evento immunizzante: o la guarigione dall’infezione o la vaccinazione. E aggiungono che il passaporto dovrebbe avere durata limitata perché non è ancora chiaro quanto persista nel tempo l’immunità stimolata dall’infezione e dalla vaccinazione.
Mercoledì, per esempio, sono stati pubblicati, sempre su Lancet, i risultati di uno studio osservazionale condotto in Danimarca che ha stimato la riduzione del rischio relativo di infettarsi con SARS-CoV-2 durante la seconda ondata di coloro che si erano già infettati durante la prima ondata rispetto a coloro che invece non si erano infettati. Nella popolazione generale questo rischio si riduce di 5 volte, ma per gli over 65 la riduzione del rischio è “solo” di 2 volte, anche se con ampio margine di incertezza.
Per quanto riguarda la vaccinazione, non ci sono ancora dati sufficienti a capire la durata dell’immunità stimolata visto che le campagne vaccinali di massa sono cominciate da troppo poco tempo.
C’è infine il problema della trasmissione dell’infezione. Non è ancora chiaro se le persone guarite o vaccinate siano in grado o meno di trasmettere l’infezione. I dati raccolti nelle campagne vaccinali in stadio più avanzato, come quelle israeliana e britannica, suggeriscono che i vaccinati abbiano una carica virale minore e dunque siano meno contagiosi. Ma non ci sono ancora prove definitive a riguardo. Questo problema non riguarda però tanto il certificato verde digitale proposto dalla Commissione perché, come abbiamo già detto, permetterà solo di essere esentati dalla quarantena preventiva all’arrivo. Per il resto finora i paesi europei raccomandano alle persone vaccinate di rispettare le stesse misure di distanziamento sociale imposte ai non vaccinati (contrariamente ai CDC statunitensi che le hanno rilassate leggermente).
Gli aspetti etici
Un anno fa Natalie Kofler e Françoise Baylis, esperte di bioetica, firmavano per Nature un editoriale molto critico verso i passaporti di immunità. Oltre a problemi di natura pratica, sollevano alcune obiezioni di natura etica: il rischio di erodere la privacy dei cittadini, l’introduzione di una nuova forma di discriminazione tra gli immuni e i non immuni, il rischio che i passaporti di immunità venissero poi ampliati per raccogliere anche altre informazioni sanitarie (ad esempio riguardo le malattie mentali) utilizzabili a fini discriminatori, la possibilità che i controlli legati al passaporto fossero indirizzati più frequentemente verso gruppi minoritari, l’incentivazione di comportamenti pericolosi per la salute pubblica (persone che cercano di infettarsi di proposito per guadagnare l’immunità).
Infine aggiungevano: «Se si realizzerà l'accesso universale, tempestivo e gratuito alla vaccinazione, allora potrebbe essere eticamente ammissibile richiedere la certificazione del vaccino per la partecipazione a determinate attività, ma se l'accesso ai vaccini sarà in qualche modo limitato, allora alcune delle disuguaglianze che evidenziamo potrebbero ancora essere applicate, come attesta la letteratura sull'adozione di altri vaccini». Si riferivano agli studi che hanno constatato che in generale l’adozione dei vaccini è più bassa tra le famiglie più povere e meno istruite.
Di diverso avviso sono invece i firmatari dell’editoriale pubblicato su Lancet tre settimane fa e anche Andrew Bailey, filosofo alla University of Guelph, che espone i propri argomenti in questo commento su The Conversation.
I loro argomenti sono sostanzialmente due. Primo: privare le persone delle loro libertà personali chiedendogli di rimanere in casa e limitare al massimo i propri contatti sociali è una misura estrema e non è giustificata nel caso in cui la persona ponga un rischio minimo o nullo per sé e per gli altri. Secondo: potrebbe succedere che comunque le aziende chiedano ai loro dipendenti una qualche forma di certificato per tornare a lavorare e allora non è meglio che siano le istituzioni a farlo in modo da poterne stabilire le regole e monitorarne il funzionamento?
Le obiezioni riguardo il rischio di discriminazione derivante da un accesso diseguale ai vaccini restano però estremamente rilevanti viste le difficoltà che stanno caratterizzando la campagna vaccinale europea. Senza contare il fatto che i cittadini dei paesi in via di sviluppo sarebbero penalizzati, visto che sono per ora sostanzialmente esclusi dalle vaccinazioni.
La proposta della Commissione di rilasciare il certificato anche sulla base del risultato negativo di un test diagnostico risponde a questa obiezione. Tuttavia, non è priva di controindicazioni.
I test diagnostici
In primo luogo è da vedere se il sistema sanitario sarà in grado di assicurare l’esecuzione di tanti test probabilmente concentrati in poche settimane estive a ridosso delle partenze. Se così non fosse, i cittadini saranno costretti a rivolgersi alle strutture private pagandoli di tasca propria e questo discriminerà coloro che non possono permettersi di pagare il tampone, magari per tutta la famiglia che vuole spostarsi insieme.
C’è poi un ulteriore quesito che nasce dalla scelta di includere i test antigenici rapidi. In generale questi test hanno un elevato livello di specificità (tasso di veri negativi) ma un livello di sensibilità (tasso di veri positivi) più basso dei test RT-PCR. Ammettiamo che vengano utilizzati solo i test con livelli di sensibilità e specificità sopra le soglie raccomandate dagli ECDC (sensibilità superiore al 90% e specificità superiore al 97%): qual è la probabilità di vedersi ingiustamente negato il certificato?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo calcolare la probabilità di essere negativi se il risultato del test è positivo usando il teorema di Bayes. Il risultato di questo calcolo dipende dalla specificità e dalla sensibilità del test, ma anche dalla prevalenza dell’infezione nella popolazione.
Se la prevalenza è bassa, la probabilità di essere negativi pur risultando positivi al test rapido può essere molto alta. Per esempio, se la prevalenza dell’infezione è di 50 casi ogni 100 000 persone, la sensibilità del test è del 90% e la specificità è del 98%, la probabilità di essere negativi pur essendo risultati positivi al test è del 98% circa. Se si utilizzasse un test più sensibile, diciamo 98%, e più specifico, diciamo 99,9%, la probabilità di essere negativi pur avendo ricevuto responso positivo dal test è comunque molto alta, pari al 67% circa.
Per questo gli ECDC suggeriscono di confermare i risultati positivi con test RT-PCR quando la prevalenza è bassa.
Se questa estate ci trovassimo con una bassa prevalenza dell'infezione allora saremo esattamente in questa situazione. Cosa succederebbe quindi? Molte persone si vedrebbero costrette a confermare il risultato con un test RT-PCR. Quanto saranno accessibili questi test, sia in termini economici che pratici?
Per ricevere questo contenuto in anteprima ogni settimana insieme a sei consigli di lettura iscriviti alla newsletter di Scienza in rete curata da Chiara Sabelli (ecco il link per l'iscrizione). Trovi qui il testo completo di questa settimana. Buona lettura, e buon fine settimana!