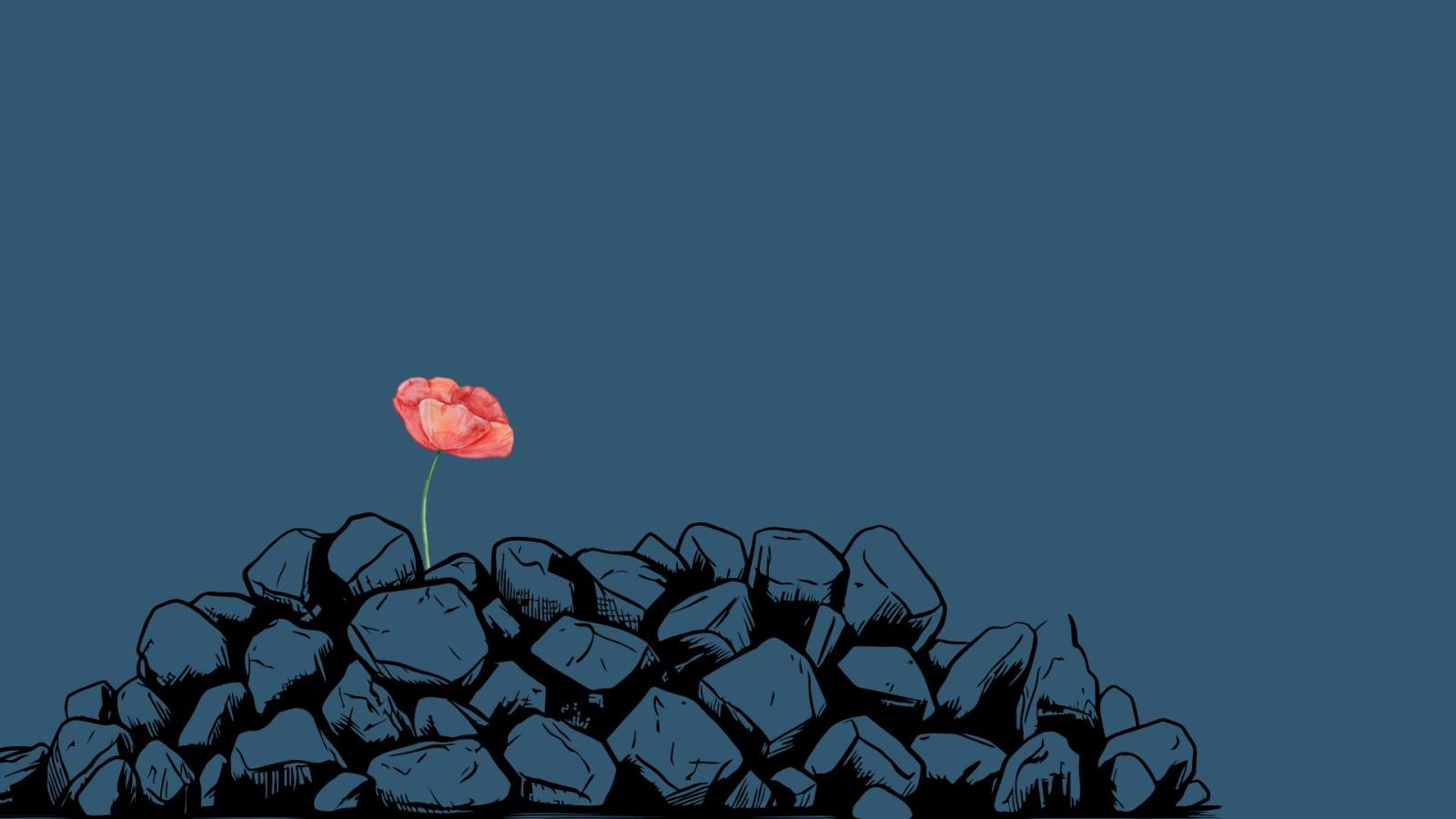Il 28 maggio scorso è apparso sulla rivista Nature il risultato di un lavoro condotto da alcuni ricercatori giapponesi su primati non umani transgenici, capaci di trasferire il gene esogeno alla progenie. Erika Sasaki e colleghi hanno utilizzato vettori virali per veicolare il gene codificante la proteina fluorescente GFP (Green Fluorescent Protein) in embrioni di scimmie marmoset, successivamente impiantati in madri surrogate. Quattro delle cinque scimmie nate esprimono il gene ricombinante in diversi tessuti, due di queste nella linea germinale e una ha generato un neonato transgenico, risultato prima d'ora mai realizzato (1). Già nel 2001, infatti, all'Università di Pittsburgh era stato creato un primate transgenico, una scimmia rhesus macaque, che però non aveva mai trasferito il gene esogeno alle generazioni successive.
Il risultato ottenuto dai ricercatori giapponesi rappresenta da una parte un traguardo scientifico che permette di guardare alla generazione di primati non umani come modello di studio nel campo della medicina rigenerativa e della terapia genica di alcune patologie. Dall'altra parte esso suscita interrogativi e perplessità circa l'applicazione delle nuove tecnologie di transgenesi sull'uomo e chiama in causa questioni relative a quel recente settore della riflessione bioetica noto come "etica animale".
Le ricerche attuali hanno gettato nuova luce sul nesso tra tecnologie e valori che legittimano i nostri comportamenti verso il mondo dei viventi. Significativo è il caso del Progetto Grandi Scimmie Antropomorfe (Great Ape Project) che propone il riconoscimento di alcuni diritti alle scimmie antropomorfe, quali il diritto alla vita, alla protezione della libertà individuale e alla protezione dalla tortura fisica. Sostenitori del progetto sono i filosofi Paola Cavalieri e Peter Singer che hanno curato il libro Progetto Grande Scimmia nel quale viene sottolineato come le scimmie antropomorfe siano capaci di manifestare sentimenti e capacità comuni all'uomo.
In questo contesto in Italia il Comitato nazionale per la bioetica ha assunto posizioni ben precise, affrontando non solo il tema più generale del rapporto uomo-mondo animale, ma discutendo in modo particolare delle giustificazioni etiche nell'uso degli animali per scopi scientifici.
Sperimentazione animale: un esercizio di mediazione. E' questo il concetto cardine che emerge dal parere del CNB che suggerisce una corretta interazione tra dati scientifici e istanze morali: la sperimentazione animale, infatti, appare difficilmente sostituibile e, allo stesso tempo, la tutela degli animali risulta imprescindibile (2). Più in generale è necessario procedere alla configurazione di un quadro normativo entro cui iscrivere nuove chiavi interpretative su alcune questioni scientifiche controverse. Ciò non significa tradurre tout court le nostre paure verso i progressi scientifici e tecnologici in limitazioni della ricerca e delle sue applicazioni.
Ma queste paure sono fondate? In riferimento alle tecniche di transgenesi sull'uomo e alla terapia genica germinale, tutto ciò è davvero possibile? Teoricamente sì. È possibile iniettare un gene esogeno nel nucleo di un uovo umano fecondato. Ma di fatto no, per ragioni di carattere tecnico ed etico. Vista la bassa probabilità di successo riscontrata in modelli murini, bisognerebbe avere a disposizione un altissimo numero di uova fecondate. Bisognerebbe, inoltre, superare alcune problematiche legate alla procedura relative all'integrazione casuale dei transgeni e ai connessi eventi biologici. In altri termini, come il professore Gabriele Milanesi ha scritto, creare un uomo transgenico allo stato tecnologico attuale sarebbe un gioco d'azzardo (3). E dunque? Occorre innanzitutto sgomberare il campo da paure che agitano l'immaginario collettivo, esercitando, come suggerisce Eugenio Lecaldano, una grande vigilanza etica senza mettere aprioristicamente al bando i nuovi traguardi della sperimentazione (4). Utilizziamo la ricerca scientifica come strumento positivo per spostare la frontiera della conoscenza, migliorare la qualità della vita e l'efficacia delle terapie, ma valutiamo sempre con responsabilità e rigore tutte le sue possibili applicazioni, lasciando da parte schematismi ideologici o dogmatici.
Note
- Generation of transgenic non-human primates with germlines transmission, Nature, Vol 459, 28 May 2009
- Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi 17 aprile 1997, www.governo.it/bioetica/testi/301101umana.html
- I Geni Altruisti, Gabriele Milanesi, Mondadori
- Bioetica. Le scelte morali, Laterza, 1999