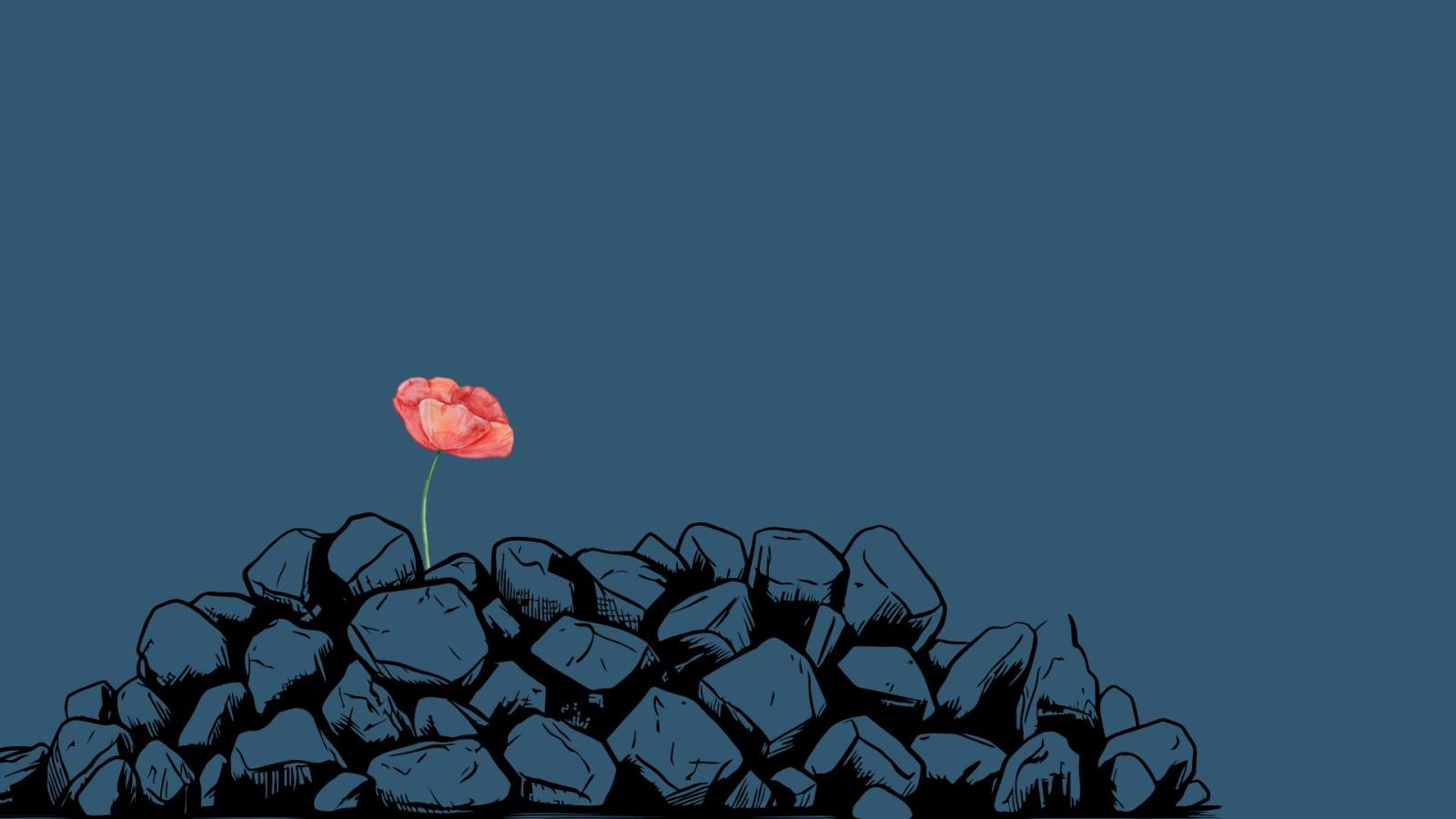La Laguna di Venezia si riscalda più velocemente del previsto. Ricerche intraprese dall'Università di Southampton e ricercatori associati hanno rivelato che, nella zona circostante la città, la temperatura superficiale del mare (SST, sea surface temperature) si sta alzando al ritmo di 1,3° C ogni dieci anni, dieci volte più rapidamente della media globale di 0,13°C per decade. I risultati, frutto di quindici anni di osservazioni, sono stati presentati dal Professor Carl Amos durante la 51esima conferenza annuale della Estuarine & Coastal Sciences Association.
Gli scienziati hanno individuato la causa nel processo conosciuto come «effetto isola di calore» (urban heat island effect), che si verifica in regioni sottoposte ad un rapido sviluppo industriale ed urbano. Un fenomeno diffuso e discusso nelle analisi climatiche ma estremamente pericoloso per le delicate regioni costiere.
Nel caso di Venezia, le conclusioni della ricerca inglese hanno evidenziato la contraddizione tra i benefici del turismo, le ripercussioni ambientali e le possibili ricadute sull'economia della città e dell'area circostante. Dalle analisi del trend della temperatura delle acque lagunari è emerso un aumento, durante i mesi invernali, 10 volte superiore a quello previsto dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Un risultato, secondo gli scienziati, direttamente connesso al turismo. Con 22 milioni di visitatori all'anno, Venezia è tra le destinazioni turistiche più apprezzate al mondo. Migliaia di posti di lavoro e parte dell'economia veneziana dipendono dall'industria della pesca, che a sua volta dipende dalla temperatura delle acque della Laguna e della zona circostante. Un aumento della SST riduce i livelli di ossigeno nell'acqua, danneggiando gli habitat di molte specie marine e causando la morte di quelle che non possono spostarsi, come quelle allevate negli ambienti di acquacoltura.
Secondo Carl Amos, la massiccia urbanizzazione delle zone costiere rende le isole di calore un problema urgente, in particolare per l'industria della pesca e per il mantenimento delle infrastrutture sulle coste. La difficoltà di valutare e prevedere gli impatti nei singoli casi, come quello veneziano, ha fatto sì che per lungo tempo il problema non sia stato adeguatamente affrontato. «Il rapporto Marine Climate Change Impacts Partnership del 2006 afferma che la capacità di stabilire e prevedere i mutamenti costieri di lungo periodo dovuti ad attività umane è sconosciuta e l'affidabilità dei risultati è bassa. Questa è un ostacolo enorme alla pianificazione delle inevitabili alterazioni della temperatura superficiale costiera. La maggior parte di questi cambiamenti sono causati da fattori di origine antropica ma la difficoltà di considerare accuratamente questi fattori ha fatto sì che l'IPCC abbia deciso di escludere le anomalie costiere dalle analisi».